
Rosa Genoni
Rosa Genoni è l’artefice di uno stile di “pura arte italiana”, capace di fronteggiare il monopolio della moda francese. Valtellinese di umili origini, Rosa comincia a 10 anni come “piscinina” e tuttofare a Milano presso la sartoria di una zia, ma presto diventa sarta e, dopo un apprendistato in Francia, si forma come stilista, diventando poi designer e docente. Nel 1905 dirige un corso di sartoria presso la Società Umanitaria di Milano e un anno dopo, all’apice del successo, ottiene il Gran Prix all’Expo di Milano. Le sue creazioni si ispirano ai maestri dell’arte rinascimentale, ma pensano anche a una donna nuova e indipendente. E non è solo questione di moda: al lavoro Rosa affianca l’attività in favore dell’emancipazione femminile. Entrata in contatto col mondo femminista e con il movimento socialista, si batte insieme all’amica Anna Kuliscioff per la riduzione dell’orario di lavoro e l’istituzione del congedo di maternità. Fautrice di un’appassionata campagna pacifista allo scoppio della Grande Guerra, si impegna in attività filantropiche a sostegno dei profughi. Nel 1915 è l’unica rappresentante italiana al Congresso internazionale delle donne all’Aja.

La dottora dei poveri
«Mi auguro, per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po’ più di solidarietà fra le donne. Allora forse si avvererà la profezia del più grande scrittore del nostro secolo – Victor Hugo – che presagì alla donna quello che Gladstone presagì all’operaio: che cioè il secolo XX sarà il secolo della donna»
Anna Maria Mozzoni, Alessandrina Ravizza, Ada Negri, Sibilla Aleramo sono solo alcune di quante si prodigarono tra Otto e Novecento per affermare i diritti delle donne. La loro attività si espresse soprattutto nel “femminismo lombardo” che aveva tre obiettivi principali: a) centralità della donna nella costituzione della democrazia; b) ruolo materno come titolo della cittadinanza e c) rivendicazione della libera disposizione di sé. Un tale approccio, però, fu solo in parte condiviso dalla principale protagonista del socialismo e del femminismo italiano, Anna Kuliscioff[1].
Nata nel 1854 a Moskaja (Cherson), da un’agiata famiglia di mercanti ebrei, Anna[2], dotata di una straordinaria memoria e di una eccezionale predisposizione al ragionamento logico e rigoroso, fu incoraggiata sin dall’infanzia a coltivare gli studi con maestri e governanti privati e si interessò molto presto di politica. Nel 1871 si trasferì a Zurigo per proseguire gli studi di filosofia, poiché in Russia alle donne era proibito l’accesso all’università. Testimonianza della sua indole passionale e dell’ansito paritario fu il gesto clamoroso con cui strappò il libretto universitario quando, nel 1873, fu ordinato agli studenti russi di abbandonare l’università di Zurigo, pena la non ammissione agli esami in Russia. Ordine, tra l’altro, sostenuto dalla motivazione secondo cui le giovani russe si recavano all’estero non per assecondare il demone degli studi, ma per abbandonarsi agli impulsi del libero amore. Era una vera provocazione.
Tornata in Russia nel 1874 per dedicarsi alla politica attiva, già nel 1877 fu costretta a riparare in Svizzera, in seguito all’ondata di arresti provocati dai vari movimenti di piazza che in quegli anni agitavano non solo la Russia, ma gran parte dell’Europa. Proprio in Svizzera conobbe Andrea Costa, con il quale si trasferì a Parigi per collaborare all’Internazionale di Kropotkin[3]. Ma nel ‘78 venne arrestata ed espulsa dalla Francia e fu di nuovo in Svizzera. Di idee anarchiche, Costa si avvicinò al socialismo proprio grazie ad Anna. Erano, quelli, anni di repressione durissima, che li videro entrambi vittime di continui arresti e di processi sommari. In particolare il processo a Firenze del 1880 suscitò molto interesse nell’opinione pubblica e dette molta visibilità alla personalità della Kuliscioff.
La lontananza forzata e il temperamento geloso di Costa però incrinarono per sempre un rapporto già conflittuale. Andrea dal carcere scrive ad Anna della propria gelosia, rivolta in modo particolare a Carlo Cafiero con cui Anna, a Lugano, aveva avviato un fitto dialogo politico e umano. Alle accuse del suo compagno, la Kuliscioff replica con fermezza: «Io alla fine vedo una cosa: agli uomini come sempre è permesso tutto, la donna deve essere di loro proprietà. La frase è vecchia, banale, ma ha le sue ragioni d’essere e l’avrà chissà per quanto tempo ancora».
La sfiducia e i dissapori, inaspriti dalla lontananza, inabisseranno definitivamente nel 1885 il loro amore, dal quale nacque una figlia, Andreina.
In Svizzera la Kuliscioff aveva ripreso gli studi ed era passata dall’ingegneria alla medicina. In seguito alle numerose detenzioni aveva contratto la tubercolosi e le vennero consigliati climi più miti. Si trasferì così, con la figlia, a Napoli. Nel 1888 si specializzò in ginecologia, prima a Torino, poi a Padova. La sua tesi era dedicata alle cause della febbre puerperale, e avendone indicato l’origine batterica, aprì la strada alla scoperta che avrebbe salvato milioni di donne dalla morte dopo il parto. Si trasferì poi a Milano, dove cominciò ad esercitare l’attività medica, recandosi tra l’altro anche nei quartieri più poveri della città. Dai milanesi venne chiamata la “dottora dei poveri”.
A Milano entra in contatto con le principali esponenti del femminismo milanese, Anna Maria Mozzoni, Paolina Schiff e Norma Casati, che nel 1882 avevano formato la Lega per gli interessi femminili. Da qui in avanti l’impegno di Anna Kuliscioff nella questione femminile diviene sempre più chiaro e incalzante, sino a culminare nel bellissimo intervento al Circolo filologico di Milano, nell’aprile del 1890: Il Monopolio dell’uomo. Un intervento forte, dall’impostazione originale e moderna, che non solo considera la questione femminile da un’angolazione economica (prospettiva “obbligata” per chi come lei si considerava parte del firmamento marxista), ma che soprattutto scava tra i ritardi, le motivazioni sociali, i pregiudizi culturali che la accompagnano e che trovano le loro radici in una mentalità chiusa, gretta e in abitudini di secolare sopraffazione. L’aspetto innovativo dell’intervento di Anna Kuliscioff, però, risiede nel modo di denunciare le angherie riservate all’altro sesso. «Non farò, tuttavia, una requisitoria – così esordisce la Kuliscioff al convegno milanese -. Non è una condanna ad ogni costo dell’altro sesso che le donne domandano; esse aspirano anzi ad ottenere la cooperazione cosciente ed attiva degli uomini migliori, di quanti, essendosi emancipati, almeno in parte, dai sentimenti basati sulla consuetudine, sui pregiudizi e soprattutto sull’egoismo maschile, sono già disposti a riconoscere i giusti motivi che le donne hanno di occupare nella vita un posto degno per averne conquistato il diritto».
Se l’inferiorità della donna nasce dai privilegimaschili, superarla risulta certo assai difficile perché il predominio dell’uomo esce come consacrato da schemi sociali giuridici e politici che affondano le loro radici nella notte dei tempi e che da qui, sull’onda lunga della storia, giunge fino ai moderni a rinsaldare la catena della subordinazione femminile.
«L’esperienza di altre e molte donne – argomenta Anna – che si alternarono a deviare dal binario tradizionale la vita femminile in genere, e soprattutto l’esperienza mia propria, m’insegnarono che, se per la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affacciano molti uomini generosi, pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non è così quanto al problema del privilegio dell’uomo di fronte alla donna». E aggiunge: «Tutti gli uomini, salvo poche eccezioni, e di qualunque classe sociale, per un’infinità di ragioni poco lusinghiere per un sesso che passa per forte, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, chiesa, scienza, etica e leggi vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un sesso dominante».
Sarebbe, dunque, semplicistico attribuire l’inferiorità della donna all’egoismo e alla prepotenza maschile. È una condizione, quella femminile, assai più complicata e subdola; sì, subdola perché il passare del tempo e l’evoluzione intellettuale e morale dell’uomo ha trasformato l’antica condizione di schiavitù della donna; ma, appunto, l’ha trasformata non l’ha abolita, e anzi – auspice anche la tradizione cristiana -, quella condizione di mite arrendevolezza è stata santificata dalle stesse donne.
«I detti di San Paolo – ricorda la Kuliscioff – di San Giovanni Crisostomo, di Sant’Agostino, di Sant’Ambrogio ed altri, tutti d’accordo a chiamare la donna la porta del demonio, lo provano a sufficienza. E questi concetti, modificati e rifatti poi dalle varie chiese e soprattutto dalla chiesa cattolica, informano ancora dopo tanti secoli la sostanza delle opinioni che hanno gli uomini e, purtroppo, anche le donne stesse, sulle capacità, sulle attitudini e sui rapporti reciproci dei due sessi (…) così per le donne sono rimaste leggi ed istituzioni che hanno origine dalla forza brutale, consacrate e sanzionate dalla chiesa e diventate poi anche base dei codici civili vigenti». Da qui muove Anna per descrivere la parabola della donna, dall’eta’ primitiva agli albori della società industriale, con “l’altra metà del cielo” sempre piegata sotto il giogo della sopraffazione e dello sfruttamento. «Si potrebbe dire con Letourneau – sottolinea con forza la Kuliscioff – che il primo animale domestico dell’uomo è stato la donna, perché in condizioni dispari di lotta, essa rimaneva la vinta, ma vinta soltanto dalla forza brutale».
La prima denuncia di Anna Kuliscioff è la mancanza di solidarietà tra le donne, il loro essere divise da un’opinione dura e refrattaria agli slanci dell’emancipazione. Sebbene l’intervento della Kuliscioff ebbe una risonanza internazionale, in Italia l’eco delle sue parole si spense subito.
Nel 1891 insieme a Filippo Turati, fondò la rivista «Critica sociale», dalle cui colonne perorò molte cause, a cominciare dal riscatto delle donne, che ella sostenne in tutti i modi. Tutti, proprio tutti: promuovendone l’emancipazione intellettuale e morale, sostenendone l’indipendenza economica, difendendone i diritti. Dal primo decennio del Novecento fino allo scoppio della Grande Guerra sosterrà con tutti i mezzi possibili la battaglia per il suffragio universale, unitamente ad alcuni fra i più angolosi eretici del socialismo italiano, come Gaetano Salvemini.
Dopo la rottura con Andrea Costa nel 1885, Anna Kuliscioff e Filippo Turati si unirono in un sodalizio durato quarant’anni, che corrispose all’espressione più alta del movimento socialista in Italia. Un grande amore e un’intesa umana e intellettuale non disgiunta però dall’indipendenza di pensiero di Anna e dalla necessità di vegliare e affermare la propria individualità.
La misura di questa indipendenza sta in una boutade di Antonio Labriola, secondo il quale il socialismo italiano contava un uomo soltanto, che poi era una donna: Anna Kuliscioff. Il luogo-simbolo, che poi divenne come una specie di santuario fu il loro appartamento a Milano in via Portici Galleria al numero 23, il cui salotto venne adibito a redazione di «Critica sociale», e che fu il punto di ritrovo degli esponenti politici del tempo, ma anche l’asilo di persone comuni, come le “sartine”, che trovavano in Anna una confidente leale e generosa. E proprio da Milano la Kuliscioff sostenne concretamente la questione femminile all’interno del movimento socialista, dapprima con la legge Carcano, approvata nel 1903, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, elaborata dalla stessa Kuliscoff e presentata da Turati, e poi con la battaglia per il suffragio universale.
Agli inizi del Novecento il dibattito sul voto ruotava intorno alla richiesta di estenderne il diritto a tutti i cittadini maschi, anche analfabeti. Dell’eguale prerogativa per le donne, invece, nessuno, o quasi, si dava pensiero. Lo stesso Turati giustificava la posizione del Partito adducendo come motivo «la ancora pigra coscienza politica di classe delle masse proletarie femminili». Immediata la risposta di Anna Kuliscioff su «Critica sociale»: «Direte, nella propaganda, che agli analfabeti spettano i diritti politici perché sono anch’essi produttori. Forse le donne non sono operaie, contadine, impiegate, ogni giorno più numerose? Non equivale, almeno, al servizio militare, la funzione e il sacrificio materno, che da’ i figli all’esercito e all’officina? Le imposte, i dazi di consumo forse son pagati dai soli maschi? Quali degli argomenti, che valgono pel suffragio maschile, non potrebbero invocarsi per il suffragio femminile?».
Sulla questione del suffragio universale, inteso come estensione del voto a tutti, donne e analfabeti inclusi, Anna Kuliscioff trovò rispondenza di idee con Gaetano Salvemini, lo storico pugliese noto per il suo temperamento impetuoso.
«Ora – si lamentava Turati in una lettera alla Kuliscioff – Salvemini mi scrive che, se il suo progetto di suffragio è buono, dobbiamo farlo nostro, se cattivo, presentarne uno migliore, far subito, fare grosso, e via via con tutte le solite impertinenze, pum, pum, pum». Ma le querimonie di Turati non trovavano facile accoglienza nella Kuliscioff, che invece trovava in Salvemini una consonanza di idee, dalla condanna della politica giolittiana alla necessità di estendere il diritto al voto a tutti, analfabeti e non, uomini e donne.
Anna Kuliscioff non solo si era schierata apertamente contro le posizioni ufficiali del Partito Socialista (e quindi anche di Filippo Turati), ma aveva sempre mostrato il suo scetticismo, per non dire il suo disprezzo, nei confronti del femminismo borghese che rivendicava diritti solo per le donne appartenenti a determinate categorie sociali.
Ma nel 1912 il governo Giolitti approva una legge che, sotto il (falso) nome di suffragio universale, concede di fatto il voto a tutti gli uomini alfabeti che abbiano compiuto i ventuno anni di età, e a tutti i maschi analfabeti che abbiano raggiunto i trenta anni. Solo uomini. Un’amara sconfitta, dinanzi alla quale però Anna Kuliscioff non disarma, pessimista ma tenace. Ed ecco infatti che il 7 gennaio del 1912 fonda la rivista bimestrale «La Difesa delle Lavoratrici», che dirigerà per due anni insieme a Carlotta Clerici, Linda Malnati e Angelica Balabanoff. Nel 1914, dopo lo scoppio della guerra, le divergenze politiche con la redazione porteranno Anna Kuliscioff a ritirarsi dall’iniziativa editoriale, sulla quale, però, continuerà sempre a pesare l’eminenza del suo giudizio. Dopo la fine della guerra e l’avvento del fascismo, la rivista non ebbe vita facile. Chiuse nel 1925, anno della morte di Anna Kuliscioff. Forse non solo una accidentale coincidenza.
Proprio mentre il fascismo si affermava con tutta la sua tracotanza, Anna Kuliscioff si spegneva nel suo appartamento milanese. «È proprio difficile anche morire».
«Quando si sentì venir meno e soffocare, volle baciare tutti i suoi intimi, e si spense, senza un sussulto, senza un brivido».
Immensa la folla di persone che volle rendere omaggio alla “dottora dei poveri”, ricordata così da Pietro Nenni: «I funerali erano stati un’apoteosi per lei e per il sopravvissuto suo compagno. Ma, ai fascisti, anche l’omaggio reso a una donna insigne per sapere, preclara per carattere, da tutti stimata per la bontà senza pari, era riuscito intollerabile. Sui gradini stessi del Monumentale, mentre a mo’ di saluto io gridavo “Viva il socialismo!”, fummo aggrediti. Attorno alla bara, attorno alle corone e ai nastri, ci fu una zuffa breve e feroce dalla quale parecchi uscimmo sanguinanti e pesti. Ed era triste pensare che ciò avvenne in un cimitero e davanti alla salma di una donna che, con tutta la sua anima, con tutta la sua intelligenza aveva auspicato pace, giustizia e fraternità».
Il suffragio universale, inteso così come Anna Kuliscioff lo aveva difeso nelle sue battaglie, ossia come voto per tutti, uomini e donne, senza distinzione alcuna di sesso o di classe, sarà introdotto in Italia solo nel 1946, dopo venti anni di dittatura fascista e l’immane tragedia della seconda guerra mondiale.

Ciao Bettina!
Per salutare la cara amica Bettina Rombolà pubblichiamo anche il suo racconto “La Maestra”, una delle storie di donne del primo Quaderno dell’8 Marzo dell’associazione.
La Nostra amava tantissimo scrivere e i suoi racconti, immancabilmente, arricchivano il nostro piccolo, amato opuscolo. Qui esprime la sua gratitudine per un personaggio legato alla sua Brattiró: la Maestra che lei definiva “ “per antonomasia”
Ciao Bettina cara!
“Un personaggio femminile del mio paese, che mi piace ricordare è, senza dubbio, la “Maestra” Maria Teresa Tambuscio, che abitava vicino alla casa dei miei genitori, dove sono nata e cresciuta, fino al matrimonio. Vecchi album di fotografie d’epoca; un quaderno diario del defunto mio padre, suo allievo, in tenuta di “piccolo balilla” (gli scolari dell’epoca fascista); e soprattutto il prezioso aiuto di Sarina Rombolà, sua pronipote, nonchè mia cara amica: questi sono gli strumenti di cui mi sono avvalsa nell’indagare intorno alla figura di questa esemplare educatrice di tante generazioni di scolari. Andando a ritroso nel tempo, come in un “flashback”, riaffiorano sprazzi di momenti rimasti impressi indelebilmente nella mia memoria. La “Maestra” Maria Teresa Tambuscio nacque a Monteleone Calabro (l’o- dierna Vibo Valentia) il 13/03/1881 e morì a Brattirò di Drapia (VV) il 7/12/1964. Qui, svolse l’attività di “Maestra” nella scuola elementare, no- minata dal sindaco del Comune di Drapia, di cui Brattirò è la frazione più importante, non essendoci, all’epoca, le scuole statali. In questo centro, la Tambuscio insegnò dal 1901 al 1948. Con lei era venuta a Brattirò anche la sorella Serafina, nonna della mia amica Sarina. Al contrario della sorella, che sposò un signore del paese, dal quale ebbe dei figli, la “Maestra” scelse di rimanere nubile. Dai miei ricordi di fanciulla emerge spesso l’immagine di lei, imponente e matronale, sia da giovane donna con i capelli neri, rac- colti con un fermaglio, sia nell’età avanzata con i capelli, via via incanutiti dal trascorrere del tempo. La casa di Maria Teresa Tambuscio, la “Maestra” per antonomasia, era, per così dire, il “salotto buono” del paese, in cui si radunavano i cosiddetti “notabili”, per lo più persone che amavano la cul- tura e la conoscenza in genere. Tra queste, ricordo, c’erano: il parroco, don Pasquale Bagnato, di Tropea; il medico condotto e il farmacista. Un altro frequentatore del salotto della signorina Tambuscio fu il direttore didattico Orazio Ferro, di cui ho nitida nella memoria la slanciata figura, avvolta dal vestito di lino bianco e con il cappello di panama in testa, quando, specie d’estate, veniva a far visita alla “Maestra” dalla sua tenuta di Sant’Angelo, località nelle vicinanze di Brattirò. Habituè della casa della Tambuscio era anche mio nonno materno, don Peppe, che aveva studiato fino al quinto ginnasio e che soleva dire: “Vado dalla Maestra, donna molto colta, perchè da lei c’ è sempre da apprendere”. Rammento bene, infine, perchè un po’ più recente, il giorno della cerimonia di intitolazione della scuola elemen- tare di Brattirò alla “Prima Maestra”, presieduta dal compianto Direttore Di Renzo, il 03/05/1990. Nell’atrio della stessa scuola si conserva il busto in bronzo, su piedistallo in marmo, della “Maestra”, opera dello scultore, originario di Zungri, Michele Zappino, e offerto dall’ex alunno, ora defun- to, Domenico Pugliese, detto Micu Moretto, emigrato in Argentina negli anni 1949-50. Oltre ad essere stata la “ prima maestra” di Brattirò, la signo- rina Maria Teresa Tambuscio si è distinta sempre per l’impegno profuso quotidianamente nello svolgimento del suo lavoro e, pertanto, è degna di essere proposta come esempio alle nuove generazioni. Per queste sue doti, la “Maestra” fu insignita nel 1932 della medaglia d’argento, per gli eleva- ti meriti educativi, dall’allora Re, Vittorio Emanuele III, e nel 1948 della medaglia d’oro, sempre per meriti educativi e sociali, dall’allora Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. La “Prima Maestra” di Brattirò ha portato al paese: cultura, amore per l’istruzione e, in tempi socio economici complessi e problematici, ha contribuito alla sua crescita civile, oltre che culturale.
Elisabetta Rombolà
Quaderno dell’ 8 Marzo 2018 #1

Anna Achmatova
Anna Achmatova, pseudonimo di Anna Andreevna Gorenko (Bol’soj Fontan, 23 giugno 1889 – Mosca, 5 marzo 1966), è una delle più importanti poetesse russe del Novecento. In realtà Anna Achmatova non amava l’appellativo di poetessa, e preferiva farsi definire poeta, al maschile.
Bevo a una casa distrutta,
alla mia vita sciagurata,
a solitudini vissute in due
e bevo anche a te:
all’inganno di labbra che tradirono,
al morto gelo dei tuoi occhi,
ad un mondo crudele e rozzo,
ad un Dio che non ci ha salvato.
Sentirai il tuono
e mi ricorderai,
pensando: lei voleva la tempesta.
L’orlo del cielo
avrà il colore del rosso intenso,
e il tuo cuore,
come allora, sarà in fiamme.
Ho soltanto un sorriso.
Così. Un moto appena visibile di labbra.
E per te lo conservo:
ché è un dono dell’amore.
Non mi ami, non ne dubito
Nè mai potrai amarmi?
Perché dunque un estraneo
In tal modo mi attira?
In te vacillo, cado e mi alzo ardendo…
tu tra tutti gli esseri hai il diritto di vedermi debole.
Lascio la casa bianca e il muto giardino.
Deserta e luminosa mi sarà la vita.
Perdona se son vissuta affliggendomi,
e il sole poco m’ha allietata.
Perdona, perdona se molti
ho scambiato per te.
Le labbra si fondono nel terribile silenzio
E il cuore si spezza per amore.
Come vuole l’ombra staccarsi dal corpo,
come vuole la carne separarsi dall’anima,
così io adesso voglio essere scordata.

L’indignazione di Giovanna Elisabetta Fratantonio: la prima donna che diresse un carcere
Oggi è domenica ma sono troppo arrabbiata
per i pensieri alti, oggi voglio fare appello a tutte le amiche che leggono il mio saltellare tra libri ed autori, voglio riflette con voi. Ho letto questa mattina che un professore ordinario del dipartimento scienze sociali, politiche e cognitive di una università italiana, parlando nel corso di una trasmissione radio, ha usato nei confronti di Giorgia Meloni un linguaggio intollerabile che mostra la cloaca massima della sua mente, il disprezzo assoluto nei confronti delle donne, specie quelle che non provengono da una classe sociale “elevata”, che non hanno diritto ad esprimere opinioni diverse da quelle di questo “emerito” tizio. Il mio disprezzo per questo tizio e per chi gli ha permesso di vomitare insulti alla radio è da estendersi per qualsiasi persona che usi questo linguaggio e questo disprezzo nei confronti di qualsiasi donna, senza tener conto del partito a cui aderisce, senza tener conto di ciò che fa per vivere o che grado di istruzione abbia o a quale ceto sociale appartenga.
E’ inutile che facciamo manifestazioni contro la violenza sulle donne, che mettiamo file e file di scarpe rosse , che dedichiamo giornate di sensibilizzazione, parole di orrore ad ogni nuova violenza. Svegliamoci, non possiamo tollerare che ci siano uomini che hanno tanto disprezzo per il genere femminile e che possano insegnare o rovesciare tutto il loro livore e la loro violenza addosso ai giovani attraverso i mezzi di comunicazione.
Intanto un docente di scienze sociali ecc. dovrebbe sapere che democrazia è rispetto di chi ha idee diverse dalle sue, questa mancanza di rispetto dell’avversario politico è totalitarismo; poi nei confronti di nessuna donna va usato il linguaggio adoperato
dall'”emerito”, usare questo linguaggio significa che o le donne sono come vuole lui o lui può dire e fare ciò che vuole. Stiamo attente ragazze a non accettare che nessuna donna sia giudicata
per ciò che pensa, per come si veste, per come si atteggia, ma gli uomini violenti vanno additati al pubblico ludibrio e non devono poter influenzare i nostri figli, gli uomini e le donne di domani, i cittadini di domani.
Chiedo scusa per la veemenza ma, anche nella vecchiaia la mancanza di rispetto nei confronti delle donne, specie quando dimostrano capacità e carattere, per tenerle in posizioni subordinate mi fa infuriare.
Buona domenica !

Tropea tra i Borghi più belli del Mediterraneo, che gioia!
La città di Tropea entra nella prestigiosa guida “I Borghi più belli del Mediterraneo”curata da Claudio Bacilieri ed edita da Rubettino
Nel segno del mito.
Una brezza di vento si insinua nelle “vinee” le viuzze del centro storico, fa sbattere le tende frangisole a righe scure, amplifica le voci della strada e porta le fragranze del basilico e del rosmarino, gli odori di pesce fritto e di peperoni arrostiti. Dalle terrazze di Tropea i tramonti rosso fuoco sembrano eruttatati dalla bocca dello Stromboli. Sfuma nell’indistinto della sera il violetto delle buganvillee che di giorno accende le vinee, è un’ombra scura scende sul “Corallone”, il gruppo di case posto sulla rupe in fondo a corso Umberto I, chiamato “il borgo di sotto”. L’odore delle vecchie case, il profilo seghettato dell’araucaria, il tuono bianco che fa il mare sbattendo sulla roccia: Tropea è una continua emozione. Il mito ne attribuisce la fondazione a Ercole, di ritorno dalle famose colonne che segnavano i confini del mondo conosciuto.
Qui l’eroe vide l’approdo sicuro offerto da quella rupe ovoidale Che si spinge nel Mediterraneo come una minuscola penisola abbracciata da due grossi scogli. Su questo promontorio di tufo, dice la leggenda fondò la città chiamandola Tropea-nutrice in greco-in onore di Giunone Giunone, la sua nutrice. Tropea fu romana e cristiana, ma la prima fonte storica riguarda la presenza del generale Belisario nell’anno 535, l’inizio della dominazione bizantina. Lungo il filo delle generazioni, dalla roccia a picco sul mare gli abitanti sfruttarono l’orizzonte con il timone di veder apparire le navi saracene. Solo dal secondo quarto dell’XI secolo gli arabi non costituiscono più minaccia: i nuovi padroni sono ora i normanni, che nel punto più alto della città in alzarono la cattedrale, imponendo il passaggio dal rito greco a quello latino. Rimaneggiata più volte nel corso nel corso del tempo, stravolto all’interno dal ridondante gusto barocco, la cattedrale conserva nella sua fiancata sinistra i modi dell’architettura normanna siciliana.
Il potere normanno si sfalda e nel 1186 gli subentra L’autorità sveva, poi quella angioina, infine la città si concede agli aragonesi, con i quali entra subito in sintonia. Nell’età spagnola Tropea contribuisce all’allestimento della flotta della lega cristiana che avrebbe vinto i turchi a Lepanto. Nel Cinquecento acquista fama con il con i fratelli Vianeo, antesignani della rinoplastica : Esisteva in città un ospedale, Istituto da una nobildonna, i cui in cui i due chirurghi applicavano la loro tecniche di ricostruzione dei nasi feriti in battaglia. Dopo il terremoto del 1783 Tropea e tra le poche città calabresi a conservare il vecchio impianto urbanistico, con i vicoli i vicoli della città murata e piccoli slarghi che si aprono tra le abitazioni. L’icona di Tropea è la chiesa di Santa Maria dell’isola, posta come una corona su una rupe che emerge dal mare e che forse, prima di diventare monastero benedettino, era un luogo di culto bizantino dove si officiava il rito greco. Da qui è bello, in estate tornare in città portandosi dietro il profumo del mare, e vagare per il centro storico alla ricerca di angoli nascosti punti.
Ammiriamo i portali di granito o di tufo delle dimore patrizie come palazzo Braghò, le ringhiere dei sei e settecento a petto d’oca, il portale bugnato appunta di diamante del settecento palazzo Collareto e quello di palazzo Tocco; infondo a Piazza Ercole troviamo l’austero edificio seicentesco che ospitava il Sedile della Nobiltà. Ci sono stradine e slarchi che, solo a percorrerli, suscitano meraviglie: via Boiano, via Dardano, via Lauro, Largo Galuppi, Largo Guglielmini, Largo Municipio esibiscono portali di magnificenza barocca, finestre con spalliera di pietra, balaustre sorrette da mensoloni, chiese di sorprendente interesse come quella dei Liguorini. Ci si immagina la laboriosità degli abitanti di questi vicoli, come via dei Fabbri, dove si producevano fucili e rivoltelle. Tropea era anche la seta delle filande sparse nei suoi casali e le coperte “Impennacchiate” dei telai casalinghi, oltre ai frutti dell’agricoltura come la celebre cipolla rossa, lo zibibbo e l’ulivella. Dal mare non arrivano più i preziosi coralli, ma è tutta la città, ora, a farsi diamante nel vento della sera.
indietro

Graziella Salvato
Mio nonno era sottufficiale di Polizia e avrebbe voluto un figlio che seguisse la sua strada ma aveva sei femmine, in compenso c’ero io. Mio nonno voleva che indossassi la divisa e così é stato perché i suoi racconti mi hanno incantato, purtroppo non é vissuto abbastanza per vederlo. Dopo il Liceo mi sono laureata in Ingegneria Navale e sono stata destinata alla nave Vespucci dove ancor oggi mi trovo come Direttore di Macchina. Ho realizzato il mio sogno. In futuro potrei anche avere una famiglia ma per ora sono innamorata di Amerigo anche se ha 80 anni.
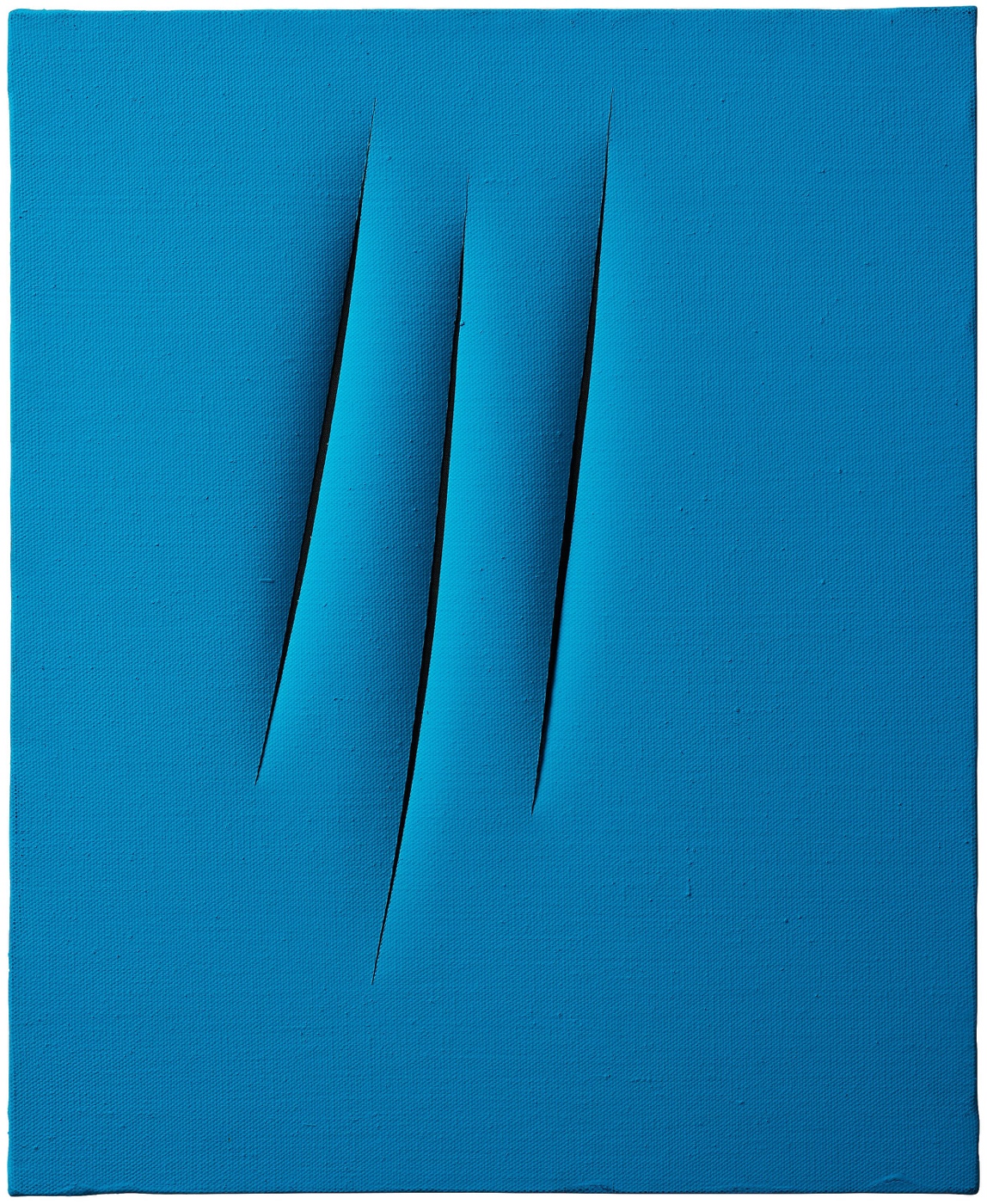
Condivisione di cordoglio e impegno
A nome dell’Associazione di Volontariato sos KORAI, impegnata nella salvaguardia della dignità della Persona oltre che nella tutela e valorizzazione della donna, esprimo profonda amarezza e indignazione per i recenti eventi che hanno sconvolto la comunità tropeana con la profanazione del cimitero cittadino. Quanto accaduto conferma l’esigenza di impegnarsi sul versante dell’educazione e della cultura per promuovere una crescita che sia veramente di tutti. Ci uniamo al dolore che unisce Tropea ed esprimiamo la nostra profonda solidarietà al Primo Cittadino che la rappresenta e in quanto tale avverte più di tutti il peso dell’offesa arrecata alla Città. Non scoraggiamoci ma armiamoci di coraggio moltiplicando il nostro impegno per la crescita comune, Tropea é ricca di energie positive che sapranno contrastare ogni male. Tropea 9 Febbraio 2021
La Presidente di sos KORAI Dott.ssa Beatrice Lento

Norma Cossetto, martire delle foibe
«Ancora adesso la notte ho gli incubi, al ricordo di come l’abbiamo trovata: mani legate dietro alla schiena, tutto aperto sul seno il golfino di lana tirolese comperatoci da papà la volta che ci aveva portate sulle Dolomiti, tutti i vestiti tirati sopra all’addome […] Solo il viso mi sembrava abbastanza sereno. Ho cercato di guardare se aveva dei colpi di arma da fuoco, ma non aveva niente; sono convinta che l’abbiano gettata giù ancora viva. Mentre stavo lì, cercando di ricomporla, una signora si è avvicinata e mi ha detto: “Signorina non le dico il mio nome, ma io quel pomeriggio, dalla mia casa che era vicina alla scuola, dalle imposte socchiuse, ho visto sua sorella legata ad un tavolo e delle belve abusare di lei; alla sera poi ho sentito anche i suoi lamenti: invocava la mamma e chiedeva acqua, ma non ho potuto fare niente, perché avevo paura anch’io”
Dal racconto di Licia Cossetto, sorella di Norma

Vietato il test di verginità in Pakistan
Il 4 gennaio l’Alta Corte di Lahore, in Pakistan, ha vietato i test per verificare la verginità delle vittime di stupro perché «invasivi e una violazione della privacy e del corpo della donna».
La decisione è stata ammirata dai movimenti femministi rappresentando una pietra miliare nel diritto del paese. La giudice Ayesha A. Malik, che fa parte dell’Alta Corte di Lahore dal 2012, ha evidenziato come di fatto, la pratica sia sostanzialmente inutile, umiliante e possa anche provocare danni fisici.
Secondo quanto riportato da Al Jazeera la violenza contro le donne è molto comune in Pakistan. Il sesso prematrimoniale è considerato un crimine (per donne e uomini) e può portare a cinque anni di prigione, anche se la legge è raramente applicata.
Nel verdetto la giudice Malik ha ribadito la colpevolizzazione delle persone che denunciano violenza sessuale, spesso descritte come «avvezze al sesso, donne di facili costumi, abituate ai rapporti sessuali», quindi più facilmente esposte a denunciare falsi stupri e molestie.
In una ordinanza governativa di dicembre sono state inasprite le pene per chi compie violenze sessuali, con la legalizzazione della castrazione chimica.
