
Goliarda Sapienza
Goliarda non esiste. Lei è l’esistenza», dicevano di lei, scherzando, alcuni amici per intendere un tratto della personalità che caratterizzava sia la donna che l’artista: mettersi sempre in gioco e sempre con estrema passionalità. Era un tipo di donna che incuteva negli altri desiderio di autenticità. E ancora oggi lo fa: attraverso la sua opera letteraria.
Leggere opere come L’arte della gioia (Einaudi), Lettera aperta (Sellerio), Il filo di mezzogiorno(Baldini&Castoldi), L’università di Rebibbia (Rizzoli) e alcune poesie ed opere teatrali rimaste ancora inedite può risultare irritante. Tale è l’insistente e spietato svelamento delle contraddizioni e imperfezioni della «bugia-realtà», in un andirivieni stilistico volutamente incompiuto che punta dritto all’animo di chi legge. Goliarda, attraverso una scrittura politica e intimista al tempo stesso, svela l’estrema problematicità dell’esistenza umana, ma anche la prospettiva di una vita migliore: se si osa contattare ogni parte di sé, senza escludere sofferenze, ambiguità, bugie, contraddizioni, paure, desideri e delitti, simbolici e reali.
Goliarda Sapienza nasce a Catania il 10 maggio 1924. I suoi genitori – la nota sindacalista lombarda Maria Giudice (1880-1953) e Giuseppe Sapienza (1880-1949), un avvocato socialista – si conoscono quando sono entrambi vedovi e quarantenni, con tre figli l’uno e sette l’altra. La loro intesa è sia sentimentale che politica: dirigono il giornale «Unione» e partecipano attivamente alle lotte per l’espropriazione delle terre in Sicilia, nel biennio 1920-22, durante il quale il figlio maggiore di Giuseppe, Goliardo Sapienza, viene trovato morto affogato in mare, presumibilmente ucciso dalla mafia, che difendeva gli interessi dei proprietari terrieri.
Il nome ricevuto dal fratello morto tre anni prima della sua nascita è solo uno dei “pesi” dell’infanzia di Goliarda, segnata dalla morte di altri tre fratellastri, poco più che adolescenti; dalla sempre maggiore sofferenza e instabilità mentale della madre antifascista e idealista; dalla vitalità e passionalità del padre che non vuole rinunciare a nessun piacere della vita: ha molte donne, si dedica con fervore al suo lavoro di “avvocato del popolo”, ed è molto amato da tutti, in un’epoca difficile come quella fascista.
Le doti artistiche di attrice, ballerina, cantante e affabulatrice della parola emergono fin da quando Goliarda è bambina ed adolescente, in cui ai “successi” di enfant prodige si alterna una salute precaria e l’insorgenza di malattie lunghe e gravi, come la difterite e la TBC.
Nel 1943 si trasferisce con la madre a Roma, dove frequenta l’Accademia d’Arte drammatica, allora diretta da Silvio D’amico. Fare l’attrice le piace perché attraverso la recitazione può esprimere la pienezza e contraddizione del suo animo, ma non le piace il mondo falso in cui spesso vivono attori e attrici di successo. Alla fine del corso non si diploma, e, contestando gli insegnamenti retrogradi dell’Accademia, forma una compagnia di avanguardia insieme ad altri ex studenti contestatari, attratti, come lei, dal metodo Stanislavskj.
Nel 1947 incontra il regista Citto Maselli: ha inizio una relazione fortissima, simbiotica, ma aperta a nuovi incontri, durata oltre 18 anni, e che, anche dopo la sofferta separazione, si trasfomerà in una sincera amicizia. Entrambi vivono tutto molto febbrilmente, ma Goliarda non resta in superficie e sa cogliere, in ogni situazione e persona, il risvolto poetico che poi trasporterà in letteratura.
Prima di diventare scrittrice la vita di Goliarda è intensa. Frequenta ambienti esclusivi e lavora, oltre che con Maselli, con registi come Luigi Comencini, Alessandro Blasetti, Cesare Zavattini e Luchino Visconti: prendendo parte attivamente alla corrente del neorealismo italiano, luogo per eccellenza di partecipazione civile, politica e morale di quel tempo. Vivendo direttamente, ma in maniera critica, il mondo artistico, impara a riconoscerne le contraddizioni e a costruirsi una personalità propria, che la scrittura letteraria fa emergere in tutta la sua potenza.
Ma il suo animo, tramato da tante tessiture emotive, predisposto a grandi entusiasmi e grandi disfatte, la porta a tentare il suicidio: dapprima nel 1962 (in seguito al quale subisce una serie di elettroshock) e poi nel 1964. Dal coma che ne consegue Goliarda traghetta in tuttaltro luogo esistenziale rispetto all’ambiente di intellettuali, artisti e “cinematografari” che per tanti anni aveva esercitato su di lei un grande fascino: un luogo più luminoso, ricco e sano, in cui l’elaborazione del lutto si trasforma in rinascita e apertura alla ricchezza umana, e in capolavori come L’arte della gioia.
Goliarda Sapienza muore il 30 agosto del 1996, scrittrice senza fama, ex attrice del neorealismo italiano. Ma è oggi riconosciuta tra le maggiori autrici letterarie italiane del Novecento.
Giovanna Providenti

Il 23 agosto 1615 Tropea torna libera anche grazie alle sue Donne!
Il 23 agosto 1615 Tropea torna libera, l’episodio, è carico di interessanti risvolti ed io colgo l’aspetto che più mi è congeniale legato al ruolo della donna nella società del tempo. Sappiamo che le Tropeane, anche le più umili, offrirono i loro gioielli e che vissero appassionatamente la vicenda talchè i maschi concedettero loro di partecipare ai festeggiamenti e persino di bere vino. Nel Seicento, le donne italiane incominciano a realizzarsi intellettualmente ma il fenomeno resta limitato alle classi privilegiate e confinato nei loro salotti, effettivamente non abbiamo notizie di donne protagoniste dell’importante evento ma è molto probabile, ed io voglio pensarlo, che ci furono anche figure femminili di rilievo che non passarono alla storia solo a causa del maschilismo imperante. Del resto Tropea fu sempre una Città eccezionale e dal respiro universale: la prima scrittura del suo nome la troviamo legata a quella “Irene conduttrix massae Trapeianae” che viene a noi dalle lapidi del passato e il mio genere é stato sempre antesignano dell’emancipazione, donne libere, dinamiche e intraprendenti…ieri come oggi.

Architetta
L’INTERVISTA
Di recente vi siete opposte, definendola “discriminatoria”, alla Festa dell’architetto 2019. Perché avete scelto di non partecipare?
Il Premio e la Festa anziché rivolgersi a entrambe le figure professionali ne riflettono solo una, singolare, maschile: l’Architetto. Non riteniamo paritetico escludere a priori dalla lingua la presenza delle donne in architettura. Le indicazioni del MIUR e dell’Accademia della Crusca sono molto chiare a riguardo: esprimono con determinazione la necessità di un utilizzo non discriminatorio della lingua italiana. Risale al 1987 il pionieristico lavoro di Alma Sabatini “Il sessismo nella lingua italiana”.
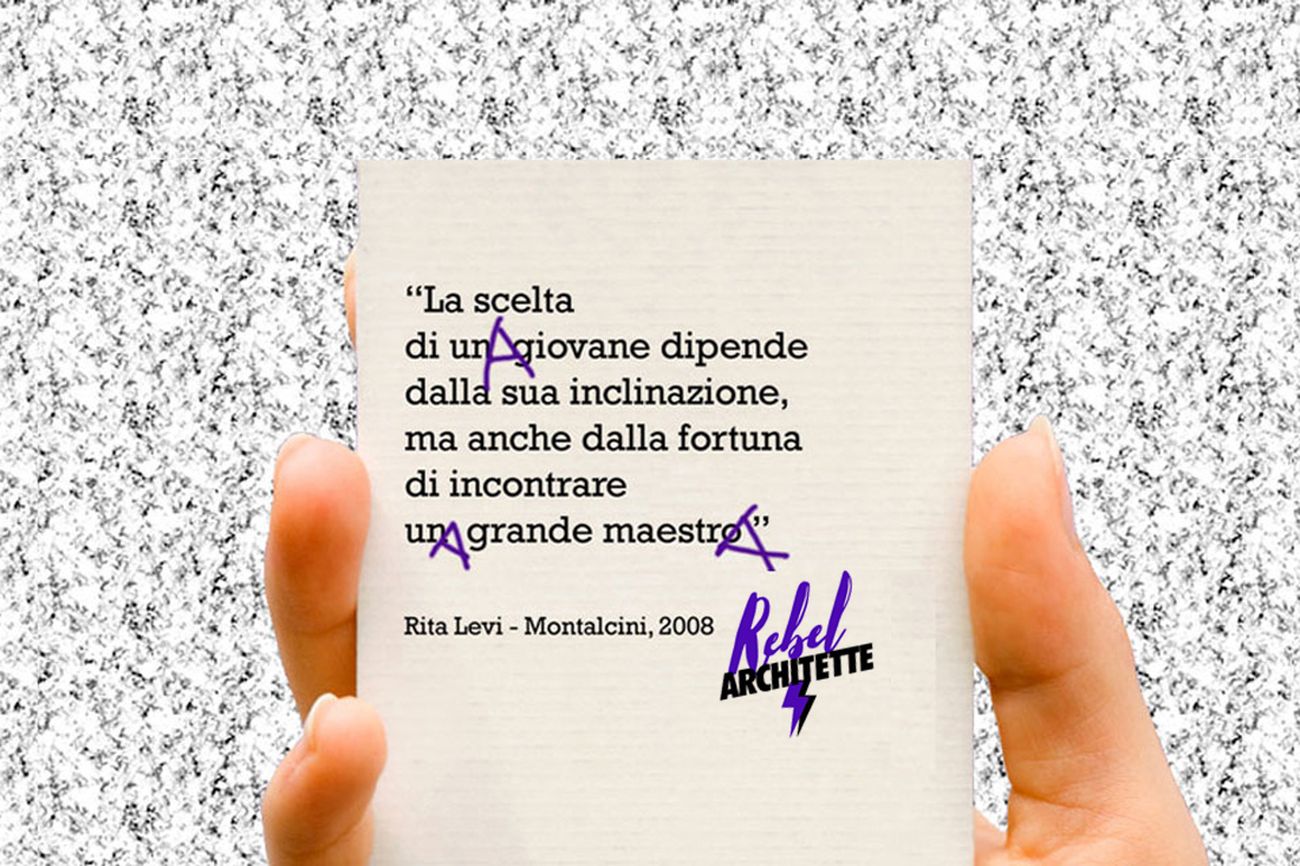
Però non candidandovi al premio, non avete dato una chance di visibilità al vostro lavoro…
Qualora avessimo partecipato ed eventualmente vinto, avremmo ricevuto un premio che nega nel suo stesso titolo la nostra presenza come genere femminile nella professione. Credo sia abbastanza ovvio che, al nostro posto, nessun collega vorrebbe oggi sentirsi attribuire un premio intitolato al femminile. Nei due anni precedenti a questa edizione, proprio per evitare che molte iscritte si sentissero a priori escluse dal partecipare, avevamo già sollecitato il Consiglio Nazionale degli Architetti PPeC (con una richiesta ufficiale, diffusa poi online) a trasformare la dicitura in Festa e Premio dell’Architettura. Le professioniste iscritte in Italia presso gli ordini professionali stanno crescendo in modo considerevole (42%). Le under 30 superano addirittura il numero di colleghi maschi, in Lombardia rappresentano il 44,7% degli iscritti e il numero delle iscritte in università oltrepassa quello dei maschi. Quali altri dati servono per evidenziare la necessità di un trattamento equo? Non è più tollerabile continuare a utilizzare il solo termine al maschile singolare. Le architette ci sono ed è importante nominarle in modo corretto.
Esistono sì, ma non tutte riescono a definirsi tali. Questo almeno emerge dalla vostra ricerca sul ricorso al timbro al femminile da parte delle professioniste. Qual è lo scenario a due anni dall’introduzione di questa possibilità?
La risposta dei nostri organi rappresentativi riguardo all’utilizzo del linguaggio di genere e l’adozione del timbro è ancora ampiamente inadeguata. Nonostante l’approvazione del primo timbro bergamasco abbia avuto favorevole risalto nazionale e siano seguite altre campagne, a oggi sono solo cinque gli ordini che ci hanno confermato il loro utilizzo. Gli ordini professionali italiani che abbiamo contattato a riguardo sono stati 106; a rispondere all’indagine, coordinata dalle architette Cinzia Bigoni e Caterina Pilar Palumbo, appena 41. Tra l’altro, 35 ordini e il Consiglio Nazionale PPeC hanno aderito già da anni alla Carta Etica per le Pari Opportunità e l’uguaglianza nella professione di architettosviluppata dall’Associazione ADA. Sottoscrivendola si impegnano sia a costituire Commissioni di Pari Opportunità specifiche, sia a tutelare e valorizzare la figura della donna nella professione. Non capiamo come non possa ancora venire considerato strategico l’utilizzo del termine Architetta.

Veniamo a nomi e numeri.
Bergamo, Roma, Lecce, Napoli e Torino prevedono entrambi i timbri; Bergamo anche quello di Pianificatrice. Roma, Lecce e Napoli hanno aderito grazie a richieste provenienti da singole iscritte. L’Ordine di Torino ha risposto alla nostra sollecitazione approvando la declinazione del timbro proprio in questi giorni, grazie al lavoro portato avanti dal “Focus pari opportunità” coordinato dalla consigliera Rita Argento e dall’architetta Romina Botta. Otto ordini (Como, Lecco, Lodi, Pavia, Pisa, Potenza, Venezia, Vicenza) hanno colto la necessità di affrontare il tema in consiglio: ci auguriamo di conoscere i risultati nelle prossime settimane. Gli ordini di Brescia, Catanzaro, Genova, Isernia, Lucca, Palermo, Perugia, Trento, Trieste, Varese utilizzano la dicitura neutra Arch., senza specificare il genere.
Chi si è opposto?
Tredici ordini (Valle d’Aosta, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, L’Aquila, La Spezia, Mantova, Monza Brianza, Oristano, Parma, Reggio Calabria, Sondrio) hanno riferito che, non avendo ricevuto richieste in merito, non hanno ancora preso in considerazione questa attuazione. Ci sono poi gli ordini di Bologna, Massa Carrara, Milano, Teramo e Terni: hanno confermato di aver deciso, in sede consiliare, di non voler adottare la dicitura Architetta; a Milano e Massa Carrara erano pervenute diverse richieste.
Perché è così importante che il termine Architetta diventi sempre più comune?
Proviamo a fare un paragone. Se vostro figlio volesse seguire un corso di danza, a conclusione del quale lo definissero “ballerina uomo” non trovereste la cosa inaccettabile? Noi sì, e non possiamo più permetterlo. Nella lingua italiana i nomi professionali sono declinati al femminile e al maschile: con la declinazione finale a-osingolare, e-i al plurale o con l’aggiunta dell’articolo. Che sia per resistenza o per ignoranza, la sua non adozione è di fatto un’ulteriore discriminazione nei confronti delle donne.

Va tuttavia rilevata una diffusa diffidenza, se non indifferenza, di tante professioniste verso questa definizione: non tutte si riconoscono.
Molte colleghe non sono pronte a utilizzare il termine architetta, perché per decenni si sono autodefinite al maschile. Possiamo comprendere una loro personale difficoltà all’accettazione del cambiamento, ma dopo aver dibattuto sul tema per molti anni la nostra vera domanda è: come mai si nega alle più giovani, che già utilizzano il termine in università, di riconoscersi nel timbro professionale? Se vogliamo che anche le donne abbiano una professione che le rappresenti, dobbiamo favorire questa adozione linguistica perché avvenga in tempi brevi e perché favorisca altre professioni che rimangono ancor oggi intrappolate in una terminologia discriminante. Le mediche di base di recente hanno esplicitato la nostra stessa necessità grazie al lavoro del Movimento Giotto, ma vediamo difficoltà anche per quanto riguarda avvocate, ingegnere, ministre, assessore, direttrici, calciatrici, capitane, etc.
Italia VS estero. Ritenete che il panorama professionale nazionale sia ancora immobile rispetto al tema della parità di genere?
All’estero si vivono problemi simili. L’unica differenza è la maggiore consapevolezza e, dunque, la maggiore volontà di cambiamento congiunta da parte di uomini e donne. In Italia sembra non esserci ancora piena coscienza del problema. Nessuno sembra accorgersi, ad esempio, che case editrici di riviste specializzate in architettura abbiano sempre avuto una prevalenza di direttori maschi (Domus, dal 1928 a oggi, ha avuto una sola donna), che la Biennale di Architettura di Venezia non abbia mai avuto una curatrice del Padiglione Italia, oppure che interi comitati scientifici quali quello della recente Biennale di Architettura di Pisa presentino solo 2 donne su un totale di 22 membri.
Eppure qualcosa sta iniziando a cambiare…
Da qualche tempo il gruppo #boycottmanels, promosso dalla manager culturale Patrizia Asproni, dichiara che qualora si presentino conferenze sbilanciate o completamente al maschile sia gli uomini che le donne dovrebbero boicottarle non partecipando. Ci sembra un’ottima idea, dato che la discriminazione avviene anche in occasioni pubbliche. Dal nostro report #timefor50 #tempodiparità, su 411 eventi di architettura realizzati negli ultimi due anni in Italia il 37% presenta soli relatori uomini. Con #tempodiparità chiediamo espressamente che si miri a una equa partecipazione. Ma noi intanto stiamo discutendo dell’accettazione di un termine, Architetta, che in Spagna e in Portogallo è assolutamente in uso comune (arquitecta, arquiteta) e che la lingua italiana prevede da sempre.
È in arrivo la 17. Biennale di Architettura. Cosa vi aspettate da Alessandro Melis, sul fronte del Padiglione Italia?
L’esperienza internazionale di Alessandro Melis in Regno Unito lo rende un potenziale outsider, un protagonista “indipendente” da cui ci auguriamo grandi cose sia sotto il profilo delle scelte curatoriali che di sensibilità verso i temi sociali. Ci aspettiamo che scelga di rappresentare il tema chiamando a partecipare coloro che meglio lo interpretano in una formula meritocratica, allargata e quindi inclusiva. Ogni progetto di architettura dovrebbe esserlo e quindi perché non pensarlo applicato in questa occasione? Crediamo nel valore della diversità data da sguardi differenti per genere, per età e per quante differenze non ancora emerse: questo è il messaggio della nostra campagna #timefor50 #tempodiparità. L’architettura in questo momento ne ha disperatamente bisogno.

A Venezia, alla Biennale del 2018, avete fatto sentire la vostra voce. Prevedete altre azioni corali nella prossima edizione?
Il nostro coinvolgimento alla Biennale sarà coerente con gli obiettivi che contraddistinguono la nostra attività; non possiamo sapere se sarà necessario o meno. Per noi in realtà è fondamentale riuscire ad avere un impatto sulle nuove generazioni di studenti e studentesse. Al momento stiamo lavorando con una rete internazionale per fare in modo che il libro online (Architette=Women architects HERE WE ARE!), sino a oggi consultato da più di 13300 utenti da tutto il mondo, possa tramutarsi in una grande piattaforma aperta e collaborativa. Un contenitore dinamico che raccolga quanti più profili possibili di architette di talento da studiare, da approfondire, da cui trarre ispirazione, da invitare come relatrici, da interpellare come membri di giurie, come docenti e come esperte in temi specifici.
Un obiettivo verso cui puntate?
Sin da novembre 2017 diffondiamo un modulo di richiesta che ogni iscritta o iscritto può inviare direttamente al proprio Ordine per favorire l’adozione del timbro alle nuove generazioni di iscritte. È questo il nostro obiettivo principale: non lasciare che le laureate, una volta superato l’esame di Stato, si vedano applicare di default un termine maschile.
‒ Valentina Silvestrini

Precipitiamo ancora!
Durante il regime talebano, in Afghanistan alle donne non veniva permesso di uscire di casa, se non accompagnate da un tutore maschio. Il burqa era obbligatorio, non potevano truccarsi, usare smalto, indossare gioielli. Non potevano lavorare, frequentare la scuola. Non potevano ridere. Il contatto con gli uomini veniva filtrato in ogni modo. Non solo gli abiti coprivano ogni parte del corpo: lo sguardo non doveva incrociare quello di un maschio, la mano non poteva stringere quella di sesso opposto. Invisibili, impercettibili, cancellate al punto da dover limitare il rumore prodotto mentre si muovevano: il rumore dei tacchi venne vietato nel luglio del 1997. Le limitazioni si accompagnavano a punizioni esemplari in caso di trasgressione, con amputazioni e pene di morte eseguite in pubblico. Tantissime in quegli anni si sono tolte la vita.
Con la caduta del 2001, le donne hanno ottenuto alcune lente e progressive concessioni. Hanno potuto nuovamente rendersi visibili, dopo anni trascorsi dietro un burqa, non più obbligatorio. I loro passi hanno ricominciato a fare rumore nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle televisioni. È stato riconcesso loro il diritto di voto. La riconquista dell’emancipazione è stata una lotta che però continua a mietere vittime: nel 2012 ci sono stati 240 casi di delitti d’onore.
E adesso cosa ne sarà delle afghane? Il portavoce Suhail Shaheen rassicura, ma dall’Afghanistan arrivano già testimonianze che raccontano una realtà diversa. Donne cresciute libere, temono adesso di vedere offuscata quella libertà. “Sentiamo tantissime storie orribili, di ragazze portate via con la forza, costrette a sposarsi con uomini che non hanno mai visto. E allora pensiamo che l’unica cosa che possiamo fare è fuggire da qui, dalla nostra casa” raccontano al Corriere della sera Nahal e Mahvash, due sorelle, ragazze single che non hanno mai indossato il burqa e stanno pensando di abbandonare la loro casa, per non rinunciare ai propri diritti. Il Guardian raccoglie la testimonianza di persone del luogo, secondo cui nei villaggi viene chiesto un elenco delle donne non sposate tra i 12 e i 45 anni, affinché possano essere date in sposa ai soldati. Al Washington Post, la giornalista Gayle Tzemach Lemmon racconta di aver ricevuto un filmato in cui un padre disperato si sorregge la testa tra le mani: non ha idea di che fine abbia fatto la figlia 14enne, degli uomini armati l’hanno portata via. Ad inviarglielo è stata una giovane donna, che ora teme quella stessa sorte possa toccare a lei. “Siamo spaventate, piangiamo tutto il giorno”, racconta un’altra. E ancora: “Abbiamo deciso di scappare”. Lasciare l’Afghanistan, per fuggire dalle violenze. Da maggio, quasi 250mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. L′80% di loro sono donne e bambini, secondo quanto affermato da Shabia Mantoo, portavoce dell’Unhcr.
Donne come bottino di guerra, donne nuovamente cancellate. Il direttore del canale d’informazione afghano Tolo News, Lotfullah Najafizada, ha twittatosul suo profilo una foto nella quale un un uomo copre con della vernice alcuni poster che ritraggono donne su un muro a Kabul. La città si prepara al dominio talebano. Secondo quanto riferito dalla Bbc, dalle aree catturate dai talebani nei giorni scorsi hanno indicato che alle donne non è già permesso uscire di casa senza un compagno maschio e che ad alcune lavoratrici è stato detto che il loro impiego sarà ora svolto da uomini. È stato anche ordinato di indossare il burqa. “I diritti delle donne e le libertà conquistate passo dopo passo in questi venti anni, pure solo quella di potersi istruire, credo che tutto questo sia drammaticamente in forse” ha dichiarato il giornalista Toni Capuozzo a Morning News, ”È lecito aspettarsi il peggio”.
Di Silvia Renda

“La settimana scorsa ero una giornalista”, scrive sulle pagine del Guardian una giovane, rimasta anonima, “oggi non posso scrivere sotto il mio vero nome o dire da dove vengo o dove sono. La mia intera vita è stata cancellata in pochissimi giorni e so che i talebani stanno costringendo le famiglie a consegnare le loro figlie per darle ai soldati”

Rosa Genoni
Socialista, militante per la pace, femminista, sarta, prémière, creatrice di moda. Parlando di Rosa Genoni le definizioni non possono che moltiplicarsi, e due universi concepiti come separati, se non in contrasto, come moda e politica finiscono per convergere sul terreno dell’emancipazione.
Primogenita di diciotto tra fratelli e sorelle, Rosa Angela Caterina Genoni nasce il 16 giugno 1867 a Tirano, in provincia di Sondrio. Il padre Luigi è calzolaio e la madre, Margherita Pini, sarta. A dieci anni, dopo aver frequentato appena la terza elementare, Rosa viene mandata a lavorare a Milano come piscinina, apprendista tuttofare dei laboratori di sartoria, andando a ingrossare le fila di quell’immensa manodopera femminile che gravitava allora intorno alla voce “vestiario”. Avida di conoscenza e dotata di spirito di iniziativa, Rosa sale passo dopo passo tutti i gradini della professione fino a diventare “maestra”. Intanto segue le scuole serali e impara anche il francese, sognando di poter andare a Parigi, all’epoca indiscussa capitale della moda.
Mentre si appropria del mestiere, Rosa inizia a interessarsi di politica. Giovanissima, frequenta i primi circoli socialisti. Ed è proprio a seguito di una trasferta con i compagni del Partito Operaio Italiano che ha modo di approdare a Parigi, dove decide di rimanere per perfezionare le tecniche sartoriali.
Forte di questo apprendistato, al ritorno a Milano nel 1888 viene assunta dalla sartoria Bellotti, impiego che le consente di far venire anche la famiglia nel capoluogo lombardo e successivamente di aiutare i fratelli a raggiungere il fratello Emilio in Australia.
Nel 1895 inizia la collaborazione con la prestigiosa Ditta H. Haardt e Figli. In seguito, nominata première, sarà a capo di 200 dipendenti. Da direttrice, può permettersi di proporre alle clienti i suoi “modelli speciali”, come si legge in un cartoncino d’invito alle collezioni, e non solo copie degli “stereotipati modelli parigini” secondo la prassi consolidata del tempo.
Concepisce una moda nazionale come “pura arte italiana”, che svincolata dalla sudditanza ai francesi sappia trarre ispirazione dal mondo classico e dai capolavori del Rinascimento, coniugando artigianato e industria generando “ricchezza” per il Paese («i cui denari – deplorava sulla rivista “Vita d’arte” – vanno a finire al di là delle Alpi»). Con questo spirito Rosa partecipa all’Esposizione di Milano del 1906, aggiudicandosi con le sue creazioni il Gran Premio per la sezione Arte Decorativa della Giuria Internazionale (due di queste – l’abito da ballo ispirato alla Primavera del Botticelli e il Manto di corte ispirato a un disegno di Pisanello – sono conservate alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze).
Anche negli anni in cui matura la sua affermazione professionale, Rosa è costantemente impegnata sul fronte delle lotte per il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici. Seguace e grande amica di Anna Kuliscioff, nel 1893 partecipa insieme ad Anna Maria Mozzoni al Congresso socialista internazionale di Zurigo. Nella cerchia anarchica di Pietro Gori conosce Alfredo Podreider, giovane e promettente penalista milanese al quale sarà legata per tutta la vita e da cui nascerà la figlia Fanny: per molti anni la loro sarà una “libera unione”, i due si sposeranno infatti soltanto nel 1928. Nel 1905 le viene affidato il corso di sartoria e modisteria alle scuole professionali femminili della Società Umanitaria di Milano (in seguito per l’insegnamento di Storia del Costume si servirà, pionieristicamente, di una collezione di diapositive da lei appositamente fatta fare dall’editrice Minerva). Come delegata dalla Società Umanitaria insieme a Carlotta Clerici prende parte al Congresso Nazionale delle Donne Italiane nell’aprile 1908, con un apprezzato intervento sui rapporti tra “Moda e arte decorativa italiana”.
All’apice del successo, mentre la celebre attrice Lyda Borelli indossa i suoi modelli e anche la stampa internazionale parla di lei, grazie al suo impegno nasce in Lombardia il primo Comitato Promotore per una Moda di Pura Arte Italiana e Rosa non smette di farsi portavoce attraverso riviste come “Il Marzocco”, “Vita femminile”, “Vita d’arte”, di un messaggio di emancipazione, nella convinzione che “un traguardo di concreta autonomia nel campo della moda (possa) sgomberare il cammino delle donne verso rivendicazioni più impegnative sul piano civile”.
Nel clima di crescente militarizzazione che segna l’avvicinarsi della Grande Guerra, Rosa si schiera fermamente a favore del pacifismo, in opposizione alle tesi interventiste di altre, per esempio di Teresa Labriola. Nel 1914 fonda il Comitato “Pro Umanità”, per la raccolta e l’invio di aiuti ai prigionieri di guerra. Il 28 aprile 1915 è l’unica rappresentante italiana al Congresso delle Donne a L’Aja, promosso dalla nascente WILPF – Women’s International League for Peace and Freedom, dove il tema del suffragio si sposa alla causa della pace mondiale. Rosa siede al tavolo delle relatrici con i grandi nomi dell’attivismo internazionale del periodo, dall’olandese Aletta Jacobs all’ungherese Rosika Schwimmer, alle americane Jane Addams e Emily Greene Balch (entrambe future premi Nobel per la pace), e al termine dei lavori fa parte del ristretto novero di delegate che viaggiano per l’Europa per incontrare le più alte autorità e promuovere la cessazione della guerra.
Più volte sottoposta ai controlli di polizia e diffidata per la sua attività di propaganda, Rosa è attiva fino agli anni Venti nella sezione italiana della WILPF, nella quale coopera con il gruppo romano di Elisa Lollini Agnini e Anita Dobelli Zampetti (tutte e tre collaborano con i giornali socialisti “La difesa delle lavoratrici” e “Uguaglianza”). Ed è Rosa a coinvolgere la scrittrice e giornalista Virginia Piatti-Tango in arte “Agar” nelle attività delle wilpfers italiane.
Nel 1925 esce la sua Storia della Moda attraverso i secoli a mezzo dell’immagine; in precedenza Rosa aveva già dato alle stampe i volumi Per una moda italiana: modelli saggi schizzi di abbigliamento femminile: 1906-1909 e Storia del costume femminile: brevi cenni illustrativi della serie di diapositive, a testimonianza del suo intento didattico e di divulgazione della materia attraverso manuali e repertori ad hoc.
Con l’ascesa del fascismo lascia l’incarico di docenza presso l’Umanitaria, dopo essere stata insignita di Medaglia d’oro per i suoi 25 anni di insegnamento, e si ritira con la famiglia a Nervi. Né lei né Alfredo prenderanno mai la tessera del Partito Fascista.
Rimasta vedova, si trasferisce a Varese dove muore nel 1954.
Da L’enciclopedia delle donne

Quando una donna dice no è no!
Io sono contenta di essere una donna. Solo ogni tanto vorrei essere un uomo per dirmi “Ciao bella figa”.
Poi mi piacerebbe essere un uomo per fare la pipì in piedi e magari scrivere nella neve “Saluti da Bardonecchia”, oppure “La panettiera di via Cosmo usa solo lievito madre”. Anche a letto se fossi un uomo avrei meno preoccupazioni. Intanto penserei che clitoride è un filosofo greco e poi crederei a lei quando mi dice che le dimensioni non contano, l’importante è come lo usi. Senza capire che le donne si riferiscono al cervello ovviamente. Poi mi piacerebbe essere un uomo perché potrei mangiare un Calippo come mi pare senza sentirmi osservata da tutti, e perché parcheggerei meglio di come parcheggio e soprattutto potrei incazzarmi con mia moglie perché non trovo il borsone del calcetto mentre lei prepara l’arrosto, consola un’amica, allatta il figlio, compila il 740 e intanto cerca di capire quando è libero l’amante. Vorrei essere un uomo quando devo andare al bagno dell’autogrill… Guadagnerei mesi di vita! Ma soprattutto vorrei essere un uomo per comprarmi interi pacchi di calze e mutande, tre paia a un euro… e sentirmi lo stesso felice. Però sono contenta di essere una donna, anche se non mi vanno giù un sacco di cose.
Per esempio non mi va giù che il mio stipendio debba essere più basso di quello di un uomo del 45%… che se un maschio italiano più o meno ogni mese guadagna 1000 €, una donna ne guadagna più o meno 550. Perché? Perché io che sono una donna devo guadagnare di meno? I conti li faccio meno bene? Gli affettati li taglio meno bene di un uomo?
E poi ti dicono “Eh… ma va così”. Allora se va così io riduco tutto del 45%. Se faccio la casalinga il bagno lo pulisco solo a metà, se faccio la barista ogni tre clienti uno lo salto… e la sera a letto invece di fare 9 settimane e mezzo ne faccio 5 scarse e poi basta.
Sono contenta di essere una donna, ma non mi va giù che le donne che hanno avuto finalmente il coraggio di denunciare il loro compagno violento, poi non sono state protette. Non ce l’hanno fatta. Nonostante avessero già tante volte denunciato il proprio aggressore. Perché?
Perché bisogna sempre aspettare una pugnalata perché quelle merde vengano sbattuti in galera. Le donne ferite devono sentirsi protette e sicure da subito. Se loro fanno il primo passo, il secondo passo dobbiamo farlo noi. Io sono contenta di essere una donna, ma non ce la faccio a pensare che devo firmare una lettera di dimissioni in bianco se resto in cinta… e mi fa rabbia pensare che quando io vado in maternità, poi non sono più sicura di ritrovare la mia scrivania al ritorno.
Non mi va giù pensare quanto sia difficile, difficile… trovare un posto per mio figlio in un asilo nido. E non sopporto l’idea che se il mio capo allunga le mani io debba tacere per non perdere il posto. E faccio anche fatica a pensare che quando io donna dico no, il mio no debba essere diverso da quello di un uomo. Perché se una donna dice no ad un uomo che la molesta, c’è sempre, sempre la convinzione che se la sia cercata. Che in fondo sia stata colpa sua. Perché quando il dito indica il maiale c’è sempre qualcuno che indica la donna e le da della zoccola. Perché magari era vestita provocante, perché era sola in giro alle tre di notte, perché… se ti fai tre mojito poi non puoi pretendere.
Allora… vediamo se arriva il messaggio! Quando una donna dice no è no! Può aver detto si a 99 uomini e voi siete il centesimo, è no lo stesso! A qualunque età, in qualunque luogo e con qualunque tasso etilico. Anzi, se lei è ubriaca e tu la molesti sei ancora più stronzo. Nessuno ti dà il diritto di toccarla, di abusarla e di violentarla. Solo perché sei più grosso, più forte o hai più potere. Quando una donna dice no è no, esattamente come quando lo dice un uomo. E poi senti cosa ti dico… non sta scritto da nessuna parte che una donna per non subire violenze, debba essere un modello di virtù, purezza e buon senso.
Mettiamo che io voglia essere puttana. Ok? Devo decidere io con chi e non sei tu che mi costringi.
Di Luciana Littizzetto

Da IL POCO DEL MONDO di Kiki Dimoula
Parla.
Dì qualcosa, qualsiasi cosa.
Soltanto non stare come un’assenza d’acciaio.
Scegli una parola almeno,
che possa legarti più forte
con l’indefinito.
Dì:
“ingiustamente”
“albero”
“nudo”
Dì:
“vedremo”
“imponderabile”,
“peso”.
Esistono così tante parole che sognano
una veloce, libera, vita con la tua voce.
Parla.
Abbiamo così tanto mare davanti a noi.
Lì dove noi finiamo
inizia il mare
Dì qualcosa.
Dì “onda”, che non arretra
Dì “barca”, che affonda
se troppo la riempi con periodi.
Dì “attimo”,
che urla aiuto affogo,
non lo salvare,
Dì
“non ho sentito”.
Parla
Le parole hanno inimicizie,
hanno antagonismi
se una ti imprigiona,
l’altra ti libera.
Tira a sorte una parola dalla notte.
La notte intera a sorte.
Non dire “intera”,
Dì “minima”,
che ti permette di fuggire.
Minima
sensazione,
tristezza
intera
di mia proprietà
Notte intera.
Parla.
Dì “astro”, che si spegne.
Non diminuisce il silenzio con una parola.
Dì “pietra”,
che è parola irriducibile.
Così, almeno,
che io possa mettere un titolo
a questa passeggiata lungomare.
[da «Il poco del mondo», traduzione di Clelia Albano]

Marija Judina
Nata nel 1899 a Nevel’, in una regione bellissima di boschi e laghi («Sono cresciuta veramente in un paradiso terrestre») più o meno a metà strada tra Mosca e Riga, Marija Judina apparteneva a una famiglia ebraica come 12 mila dei 18 mila abitanti destinati nel 1941 a essere spazzati via dai nazisti. Figlia di un medico, Veniamin Judin, laico e positivista, rivelò subito d’essere, al pianoforte, una enfant prodige. Accettata a 12 anni al Conservatorio di Pietroburgo («suonavo con il colletto “alla marinara” e la treccia»), diplomata a 22 con la medaglia d’oro (vincendo anche un pianoforte a coda bianco mai consegnato), a 24 era già in cattedra.
Una carriera fulminante. Nonostante, appunto, quella rivoluzione che sulle prime l’aveva travolta. Un giorno, come racconta Giovanna Parravicini, ricercatrice di Russia Cristiana che da trent’anni vive a Mosca, nel libro Marija Judina. Più della musica, edito da La Casa di Matriona, uscì di casa e si trovò travolta da un fiume di gente: «Per le strade si sparava, non si aveva paura di niente e noi ci davamo da fare per fasciare le ferite e rifocillare gli affamati». Finché incontrò uno dei suoi professori: «“Cos’è questa roba?” mi chiese sfiorando la mia fascia da miliziana… Io mi smarrii, dentro di me esplosero a tutta forza le ouverture di von Weber, le sinfonie di Schubert, Mozart, la mia esecuzione nell’orchestra studentesca sui timpani e non riuscii a spiegare niente… In quell’istante “l’istinto rivoluzionario” lasciò il posto in me al “senso sinfonico”».
Il resto lo fecero le delusioni. Le contraddizioni tra i proclami («Esponete liberamente le idee più sublimi. In nessun altro luogo, in nessun altro Paese verranno accolte calorosamente quanto nella Repubblica degli operai e contadini») e gli arresti di amici e compagni che «erano davvero il “fiore dell’umanità”. Disinteressati, laboriosi, tutti responsabilità, bontà fattiva, forza di pensiero… Oro puro…», ma pensavano fuori dal coro e per questo finirono in galera o «morti da martiri». Come Vsevolod Bachtin, un «astro della medievistica» e sua moglie Evgenija, che «per oltre 30 anni hanno peregrinato tra lager e luoghi di deportazione», o Sergej Usakov, scomparso «ancora ragazzino» quando sapeva «praticamente a memoria tutto Dante in italiano».
«La nostra giovinezza, la giovinezza di tanti uomini d’arte, di scienza, di vita pratica, aveva le ali ai piedi», ricorderà Judina. «E ciascuno a modo suo poteva ripetere quelle stupende parole di Blok: “Sento il fruscio delle pagine di storia che si voltano”… Ci alzavamo e ci coricavamo con la poesia». Finché tutti i sogni finirono: «L’università si spopolava. I nostri docenti insegnavano fino all’ultimo, fino all’ultima ora e istante in cui venivano soppressi la loro materia o loro stessi».
La salvò, via via che le illusioni erano inghiottite dallo sconforto, la fede: «Ieri per la prima volta sono stata alla liturgia. È proprio vero, dunque, sto approdando al cristianesimo, definitivamente; lo voglio. È la prima volta che entro in chiesa, attendo la grazia di Dio, credo e spero! Signore abbi pietà! Amen». Battezzata nel maggio del 1919 a Pietrogrado, resterà fedele a quella scelta fino in fondo. Usando per decenni i suoi soldi (pochi) e la sua fama (leggendaria tra i russi a dispetto delle cacciate prima dal conservatorio di Stalingrado e poi da quello moscovita, dell’esilio a Tbilisi, dei concerti negati…) per cercare di aiutare i dissidenti a rischio di deportazione, per pagare la retta a studenti poveri, per spendere l’intero stipendio per una mucca da latte da dare a una madre affamata conosciuta in treno, per sfidare la collera del Potere ospitando Boris Pasternak che proprio a casa sua lesse per la prima volta nel febbraio 1947 parti del proibitissimo Dottor Živago e poi ancora prendendo tra i primi le difese di Aleksandr Solženitsyn all’uscita di Una giornata di Ivan Denisovic: «Un libro epocale».
Per non dire della sfida più temeraria, raccontata dal pianista e compositore Dmitrij Šostakovic e ripresa da Giovanna Parravicini. Una sera, nella sua dacia, Iosif Stalin ascolta alla radio Marija Judina: è il Concerto numero 23 K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart. Sa bene chi è, quell’inflessibile avversaria. Sa anche però, statene certi, che nel 1942 s’era offerta volontaria per andare nell’amatissima Leningrado come infermiera e che dopo esser stata rifiutata («Non sapevo far niente: durante il tirocinio in ospedale inondavo di lacrime i feriti gravi») aveva insistito per andare nella città assediata dai nazisti per suonare in diretta alla radio e tirar su il morale dei soldati. Nonostante tutto, il despota è un suo ammiratore. Ascolta il concerto e ordina: vorrei il disco.
Ma non c’è, il disco: era tutto in diretta. Panico: come dire di no a Stalin? Occorre farlo, il disco. Nella notte (notte alla quale Ermanno Olmi sognava di dedicare l’ultimo film della sua vita prima di morire) vengono febbrilmente rintracciati la pianista, i musicisti, il direttore d’orchestra. Ore di fatica, di tensione, di arte. La mattina il disco è pronto. Stalin ringrazia inviando a Marija Judina 20 mila rubli, «una cifra strepitosa per l’epoca». Tanto più per una donna così incurante di ogni cosa superflua da venire invitata dallo stesso partito a farsi «un guardaroba decente».
La risposta è straordinaria: «La ringrazio per il Suo aiuto, Iosif Vissarionovic. Pregherò giorno e notte per Lei e chiederò al Signore che perdoni i Suoi gravi peccati contro il popolo e la nazione. Dio è misericordioso, La perdonerà. I soldi li devolverò per i restauri della mia parrocchia». Quando il despota se ne andò, si dice, sul grammofono della dacia trovarono quel disco.
Dal corriere.it
