
Stupro di gruppo
É un reato diverso da quello compiuto da un solo aggressore.
L’art 609 octies prevede condanne da 8 a 14 anni e il giudice può decidere se applicare aggravanti o attenuanti.
Tra le vittime le più colpite sono le ragazze dai 14 ai 17 anni: 50 ogni 100 mila denunciano uno stupro.
Nella fascia dai 18 ai 24 anni circa 40 ragazze ogni 100 della stessa età denunciano una violenza.
Perché non denunciano o lo fanno in ritardo?
Lo stupro é sempre devastante e quello di gruppo lo é particolarmente, spesso lo shock dura più a lungo, maggiore é la paralisi psichica, maggiore il terrore di incontrare i componenti del branco, maggiore la vergogna e il senso d’impotenza.
Il processo é sicuramente più doloroso e le vittime sono più esposte alla ” traumatizzazione secondaria”.
La battaglia legale in tutti gli stupri si gioca sul consenso della donna e spesso per portare acqua al mulino del mostro si tirano in ballo anche i social usando a proprio vantaggio eventuali immagini della vittima in atteggiamenti di serenità:” Guardate come sorride. Vi sembra così infelice.”
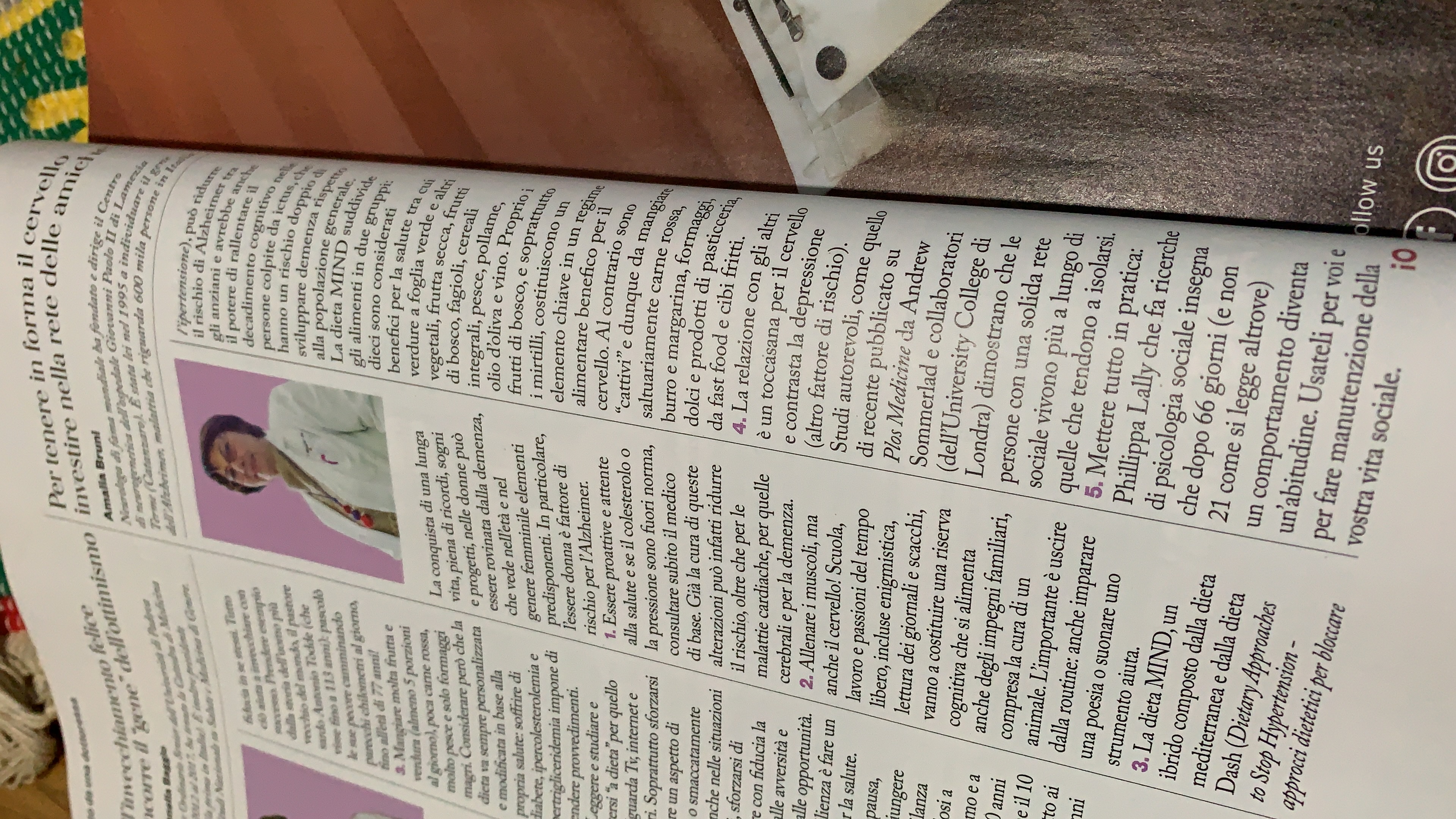
La nostra Amalia su Io donna
Siamo felici di trovare un articolo della nostra Socia d’onore Amalia Bruni su Io Donna
La nostra afferma: per tenere in forma il cervello investire nella reta delle amiche.
Auguri cara Amalia!

Le sei sorelle Mitford
Erano sei e tutte diverse. Quello che è certo è che per David Freeman Mitford, il barone Redesdale, erano un grattacapo continuo. Da buon padre conservatore ed esponente di una campagnola aristocrazia inglese di modeste rendite, per le figlie avrebbe voluto il meglio e… poche chiacchiere. Pia illusione: in famiglia era un continuo generarsi di piccole bombe a orologeria, pronte a esplodere alla minima occasione che potesse portare una qualsiasi forma di popolarità.
Erano sei per l’appunto, in ordine Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica e Deborah, più Tom, l’unico maschio, amato e rispettato, ma sempre un po’ escluso dai pazzi giri delle sorelle. Mamma Sidney, figlia di un padre armatore, era un’eccellente economa, tanto pignola e “fissata” con i conti che imponeva alle figlie il famigerato quaderno di casa da redigere quotidianamente. Dal canto loro, le fanciulle non risparmiavano alla madre soprannomi irriverenti e scanzonati. Il preferito era TPOF, the poor old female (“la povera vecchia”). Andava peggio a David, il padre, che per le terribili girl era TPOM, the poor old male (“il povero vecchio”), ma spesso era anche the poor old sub-human (“il povero vecchio sub-umano”).
Nancy (1904-1973), la prima, era una tosta e conscia di esserlo. Negli anni è diventata una scrittrice apprezzata di libri spassosi, come Non dirlo ad Alfred o Amore in un clima freddo. Non era difficile per lei scrivere commedie brillanti e irriverenti, in fin dei conti le bastava parlare della sua famiglia e il gioco era presto fatto. Questo suo modus operandi, in effetti, le costò più volte i musi lunghi di chi si sentiva canzonato sulla carta. Era un esempio di ribellione per le sorelle, che ne traevano spunto. Come quella volta che tagliò i capelli corti, alla maschio. Era il 1924, aveva vent’anni e una dose di sprezzo verso il potere genitoriale assolutamente impensabile per le fanciulle dell’epoca. In casa indossava i pantaloni «causando quasi un colpo apoplettico al padre David» scrive Mary S. Lovell in Le sorelle Mitford – Biografia di una famiglia straordinaria (Neri Pozza). Il poveretto, per sfogarsi, usciva di buon’ora e con tutta la foga della frustrazione faceva schioccare il frustino come un forsennato.
Meno problematica fu la secondogenita Pamela, detta Pam (1907-1994). La ragazza amava la campagna, indefessamente. Per lei non era solo un bel posto dove vivere, ma una ragione di vita. Se le altre ragazze consideravano noiosi i lavori da massaia, lei li riteneva quasi una professione da condurre con metodo. Questo lato del suo carattere le giocò il soprannome di Woman, donna, abbreviato in Woo, alla maniera Mitford. Le acque chete, comunque, non sono mai tali. Quando si dice che le ragazze non stavano mai buone non è un eufemismo. Spesso Sydney portava le sue figlie ai balli dell’alta società e probabilmente non scoprì mai che le pestifere sgusciavano fuori dal retro delle case, per recarsi nei locali notturni e poi ritornare su di giri alla noia della festa.
La terza, Diana (1910-2003), era sicuramente la più bella. La pelle diafana – caratteristica del gene Mitford, esaltato in lei ai massimi livelli – e gli occhi del cielo: era divina. A diciotto anni si innamorò perdutamente del rampollo della birra Guinnes, Bryan, di quattro anni più grande. Il responso dei genitori al matrimonio fu un sonoro no, con un “ripassa fra due anni”. E Diana? Per tutta risposta passò all’offensiva in modo silente. Scriveva Jessica: «La strategia di Diana (forse l’unica possibile a parte la fuga d’amore) fu mettere il muso per un intero inverno». Si struggeva e comunicava noia, guardando fuori dalla finestra con sguardo vacuo. Se ne stava così, pallida e affascinante. Alla fine i genitori dovettero cedere. Il matrimonio fu sfavillante: i due erano giovani, belli, influencer degli anni Venti-Trenta, con la casa colma di intellettuali e divi, sempre impegnati in grandi feste alla Gatsby. Dopo due figli e tante, tante feste, la bella Diana perse letteralmente la testa per Oswald Mosley, il giovane politico più brillante di quegli anni, fondatore di un suo partito, il New Party, estremizzato poi nella BUF, British Union of Fascist. Diana lo incontrò ad una festa, non capì più nulla. Ne divenne l’amante e decise di sbriciolare il matrimonio Guinness, gettando tutti nella costernazione. La moglie di Mosley di lì a poco si ammalò di peritonite e ne morì: tutti credettero fosse crepacuore. L’amante Mitford per tutti divenne “Diana l’orrore” e dal mondo dorato in cui era cadde in un declino inesorabile.
Nel nome c’era già una profezia
Assieme a Unity, Diana sarà una delle sorelle più folli, soprattutto per le scelte politiche. Unity Valkierye-Swastika (1914-1948) aveva nel nome la profezia di quanto sarebbe diventata: una nazista fanatica ed esposta, la cui vicinanza al Führer le costò molto in terra natia. Poco le importava, la Germania era la sua casa. Alta più di 1 metro e 80, la giovane amazzone si divertiva a scandalizzare: al suo ballo da debuttante si presentò con la bestiolina di casa, Ratular, il ratto bianco. A volte lasciava a casa il ratto e portava Enid, la biscia, che si sistemava sul collo. Non era brutta, tutt’altro. Molti dicevano che assomigliava a Diana, ma vista in uno specchio leggermente deformante. In foto era sempre imbronciata, ma la sua simpatia, invece, era un tratto noto. Nel 1932 si iscrisse alla BUF di Mosley, ma l’obiettivo era uno solo: conoscere Adolf Hitler. Andò a Monaco a studiare la lingua, e cominciò una vera e propria “operazione stalking”, frequentando l’Osteria Bavaria e le sale da tè del Carlton, luoghi di cui il Führer era assiduo frequentatore.
Pian piano Hitler si abituò alla visione di questa alta fanciulla nordica, sempre seduta allo stesso posto e sempre a fissarlo. Quando lui la salutò fu indimenticabile: Unity non sapeva che sarebbe diventata sua preziosa amica e certo non immaginava che per lui sarebbe morta. Quando Londra dichiarò guerra alla Germania del suo cuore, il dolore fu troppo grande e decise di spararsi in testa. Sopravvisse, ma i postumi della ferita la portarono alla morte qualche anno dopo.
La comunista di famiglia
Jessica, detta Decca (1917-1996), era la comunista di famiglia. Memorabili erano i fronti opposti ricavati nella cameretta con Unity: una riga separava la zona rossa di Decca dalla zona nera di Unity. Nonostante le divergenti visioni politiche le due erano legatissime. Annoiata dalla vita di casa, fin da piccola sognava la fuga. Non fu un caso il conto “Fuga da casa” alla banca Drummonds, aperto nell’infanzia con i suoi primi dieci scellini. Nel 1937 ebbe l’occasione per farlo e il compagno perfetto: il folle cugino Esmond Rommilly, nipote di Winston Churchill, con cui si sposò segretamente e con cui fuggì in Spagna, dove si stava consumando la guerra civile. Esmond lavorava come reporter. Quando i genitori lo scoprirono fu troppo tardi. I ragazzi erano già a Bilbao: «Buon Dio, non ha portato con sé dei vestiti per combattere» fu l’accorato commento della storica tata delle ragazze. Nel 1939 i due emigrarono negli Stati Uniti, ma nel 1941 Esmond, arruolatosi nella Royal Canadian Air Force, morì di ritorno da una missione contro la Germania.
Deborah, Debo, era la piccola di casa (1920-2014). Aveva un sogno: diventare duchessa e vivere in un posto sfarzoso. Fra tutte, fu quella che coronò le sue aspirazioni. Nel 1941 sposò infatti lord Andrew Cavendish, decimo duca del Devonshire, diventando così duchessa. Amava le galline, erano la sua ossessione. Nello splendido castello di Chatsworth era lei a sfamarle. Memorabile la foto di Bruce Weber del 1995: la duchessa in splendido abito da sera con manto in taffetà armata di secchio e mestolo dà il becchime alle sue amate. A una cena con lo stilista Oscar de la Renta mise come centro tavola scatole trasparenti con galline – vive – pigolanti. Nel 2014 la Duchessa Coccodè si spense. Era l’ultima delle sorelle, con lei se ne andò un pezzo di Inghilterra gloriosa e folle, anche se i rumors sulle sei terribili ragazze non si sono mai spenti.
Da Io Donna

Donne in manicomio durante il fascismo
Durante il Ventennio fascista, i manicomi si riempirono di donne accusate di essere libertine, indocili, irose, smorfiose o, soprattutto, madri snaturate.
Durante il Ventennio fascista, per esempio—complice l’ampliarsi della categoria della “devianza” morale e sociale—i manicomi si riempirono di donne accusate di essere libertine, indocili, irose, smorfiose o, soprattutto, madri snaturate. I ricercatori Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante hanno passato al vaglio i documenti del manicomio cittadino di Sant’Antonio Abate, uno degli storici luoghi di trattamento dei disturbi psichici e custodia di persone sgradite alla società, per raccontare le vite delle donne che vi erano recluse durante quel periodo. Ora foto, lettere e cartelle cliniche dell’archivio dell’istituto sono esposte in una mostra in corso alla Casa della Memoria e della Storia di Roma.
Ho contattato Annacarla Valeriano, della Fondazione Università degli Studi di Teramo, per parlare di devianza, ospedali psichiatrici e foto segnaletiche.
Per cominciare, da dove nasce l’idea di questa ricerca?
Annacarla Valeriano: L’idea nasce da un progetto molto più ampio della Fondazione Università degli Studi di Teramo, che nel 2010 ha iniziato a valorizzare le memorie del Manicomio Sant’Antonio Abate, che si trova al centro della città, è stato fondato nel 1881 ed è rimasto aperto fino al 1998.
Nel corso di svariati anni passati in archivio ho analizzato circa 7.000 delle 22.000 cartelle cliniche di uomini e donne ricoverati dal 1881 al 1945, facendo confluire una prima parte del lavoro—fino al 1931—nel libro Ammalò di testa. Storia del manicomio di Teramo. Sono poi tornata una seconda volta in archivio per concentrarmi sulle donne internate durante il Ventennio fascista.
Come mai ha scelto proprio questo particolare gruppo? C’era qualcosa di distintivo della situazione delle donne internate durante il Fascismo?
Durante il periodo passato in archivio mi ero accorta che sul frontespizio delle cartelle cliniche relative alle donne in epoca fascista cominciavano a comparire le foto delle pazienti. Prima era una pratica molto rara, ma durante il Ventennio era diventata diffusa—mentre, contemporaneamente, un concetto di “devianza” più ampio rispetto alla morale fascista faceva sì che le donne internate fossero sempre di più. Così ho deciso di approfondire il concetto di devianza femminile.
La foto veniva allegata con una funzione “lombrosiana”, come a voler riscontrare nei tratti somatici la figura della malattia mentale?
Sì, ma bisogna tenere presente che il regime non ha inventato nulla di nuovo, sia per quanto riguarda il principio della fotografia psichiatrica—già diffusa da fine Ottocento—sia per quanto riguarda i modelli positivisti in cui si incardina lo stereotipo della donna deviante. Secondo i principi positivisti di derivazione lombrosiana, si potevano riconoscere la devianza e la malattia mentale nei tratti fisici: nello sguardo, nell’asimmetria del volto, in uno zigomo diverso dall’alto. Ma c’era anche una ragione sociale, quella di descrivere la devianza per renderla riconoscibile e dunque controllabile—se una di queste donne fosse fuggita, si poteva rintracciarla attraverso la foto segnaletica.
Quali erano le “patologie”, le ragioni principali per cui le donne venivano internate?
Diciamo che nel carnaio del manicomio venivano internate varie tipologie di donne devianti. La categoria principale è quella delle cosiddette madri snaturate, ovvero coloro che non hanno saputo assolvere a quel ruolo materno su cui la propaganda martellava, perché già a partire dal discorso dell’ascensione del 1925 Mussolini aveva affermato che l’unico ruolo della brava donna fascista era quello della madre. E in manicomio finiscono tutte quelle donne che non sono riuscite ad andare fino in fondo a quel ruolo.
Da quali ceti sociali venivano queste donne, e in che modo si stabiliva che non assolvessero ai propri compiti?
Parliamo di donne della classe contadina, di un ceto basso che sfiorava spesso condizioni miserabili. Il manicomio attingeva le sue pazienti da una società rurale che in quegli anni era completamente destrutturata, nonostante i proclami di Mussolini riguardanti il ritorno idillico al mondo rurale e la figura della massaia rurale. Erano donne che avevano avuto magari dieci, 12, 14 figli, e che contemporaneamente dovevano svolgere i ruoli di madre, donna di casa e lavoratrice nei campi. Quando, oberate, davano segno di esaurimento nervoso—dovuto anche alla malnutrizione e all’assoluta indigenza in cui vivevano—o non riuscivano a prestare ai figli o al marito le attenzioni necessarie, venivano etichettate come “contro natura”. La stessa etichetta veniva affibbiata alle donne che soffrivano di depressione post partum o manifestavano la volontà di non volere più o non volere proprio figli.
E per quanto riguarda la devianza sessuale? Mi diceva che non erano tanto le prostitute a finire internate, dato che all’epoca c’erano le case chiuse, quanto piuttosto donne che si manifestavano particolarmente “libertine”.
Sì, anche se alcune internate potevano essere prostitute, questo era “ininfluente” a livello di quadro clinico, perché il regime aveva altri metodi di contenimento della prostituzione. Il problema per cui finivano in manicomio, in quei casi, era piuttosto la sifilide. Ma soprattutto c’era il problema delle donne e delle ragazze che si sottraevano ai ruoli sociali e alla potestà famigliare o fraterna, alcune delle quali manifestavano anche esuberanza sessuale—erano ragazze ribelli che dovevano essere ricondotte all’ordine.
Ha trovato delle storie che l’hanno colpita in modo particolare, o ha avuto modo di ricostruire qualche vicenda più straziante delle altre?
Sono affezionata a varie storie—contrariamente a quello che dovrebbe fare il ricercatore quando si avvicina a un oggetto di studio, non ho potuto fare a meno di sentirmi presa da questo vero e proprio archivio del dolore. Le cose più toccanti sono proprio le parole delle degenti, che abbiamo avuto modo di leggere dato che nelle cartelle cliniche sono raccolte le lettere che le donne—le poche alfabetizzate—scrivevano alle famiglie o alla direzione della clinica, e che poi venivano sottoposte a censura preventiva, mai spedite e allegate alla cartella clinica.
Sono spesso appelli accorati alla famiglia per essere riprese in casa, oppure alla direzione del manicomio per essere dimesse; o ancora scritti in cui raccontano la loro vita, le giornate interminabili, sempre uguali, i soprusi, il controllo, il cibo che non basta mai, il vestiario inadeguato.
Ma chi chiedeva il loro internamento, sapendo che non doveva essere un’esperienza piacevole?
Erano le famiglie stesse che chiedevano alle istituzioni manicomiali di curare la propria congiunta, per riportarla ai ruoli che aveva abbandonato—per farla tornare in sé. Il ricovero coatto di “persone alienate pericolose a sé e agli altri e di pubblico scandalo” era regolamentato dalla legge numero 36 del 1904. Di solito era appunto la famiglia a segnalarle, e allora il sindaco con l’indicazione del medico condotto poteva ordinare l’internamento—non tanto diverso dai moderni TSO. Poi, nel 1968, la legge Mariotti ha introdotto la possibilità di ricovero volontario.
Quindi l’ospedale psichiatrico era visto effettivamente come luogo di cura—cioè, l’opinione pubblica aveva fiducia in esso?
Sì, se per cura si intende quello che si intendeva all’epoca. Una finalità fondamentale dei manicomi, allora, era la custodia degli alienati, ovvero delle persone che manifestavano anomalie di comportamento. Un tratto che si coglie nella stragrande maggioranza delle cartelle cliniche di quegli anni è quella di assimilare le anomalie del comportamento a un problema psichico. Un uomo che non aveva voglia di lavorare era disturbato, così come una donna libertina veniva tacciata di “immoralità costituzionale”—che, si capisce dalla formulazione stessa, è una diagnosi che attinge alla sfera morale e non a quella psichica. In molti casi, prima dell’arrivo nel 1952-53 degli psicofarmaci, l’isolamento e la custodia erano considerati di per sé una cura.
Ma a parte la custodia, quali erano le cure che venivano somministrate?
Se ne sono avvicendate diverse: a fine Ottocento vi era una concezione della malattia mentale come scompenso fondamentalmente organico che si cercava di risolvere con bagni caldi e freddi e con la cosiddetta “terapia del riposo”, che consisteva nel tenere le persone legate al letto per lunghi periodi. Ma gli anni del fascismo sono anni di maggiore sperimentazione, in cui si cominciano a usare la malarioterapia, l’insulinoterapia e, a partire dal 1938, l’elettroshock.
In cosa consistono la malarioterapia e l’insulinoterapia?
Sono inoculazioni funzionali a provocare shock organici. Inoculando la malaria nei pazienti psichiatrici, per esempio, si provocavano accessi febbrili fortissimi, con picchi di 42 gradi, che potevano portare al risveglio dalla catatonia o uno shock seguito da repentino abbassamento della temperatura corporea, e quindi a una remissione dalla mania. Ovviamente, erano sperimentazioni molto rischiose che non tutti tolleravano bene—anche perché a volte avvenivano per due-quattro settimane di fila
Ma dai manicomi si usciva?
Sì, le cartelle cliniche infrangono lo stereotipo culturale che vuole che dai manicomi non si uscisse più. In realtà erano istituzioni porose: ho riscontrato tanti casi di persone internate e rilasciate più volte, che entravano per cure di qualche mese, poi uscivano, poi rientravano. Ma questo dipendeva sempre dal fatto che all’esterno ci fosse una famiglia disposta a riprenderle, che si prendesse la responsabilità di badare a loro. I casi di persone morte in manicomio o che ci hanno passato 50-60 anni sono legati all’assenza di parenti disposti a riprendersele.
Immagino che per le famiglie fosse anche vissuto come stigma sociale l’avere una madre, una sorella o una figlia internata in manicomio, o appena uscita.
Assolutamente sì, una volta entrate in manicomio queste donne smettevano di essere persone; non solo, perdevano anche tutti i diritti civili: il regime fascista includeva chi veniva internato in manicomio nel casellario giudiziario. Per le famiglie era motivo di grande vergogna avere un parente in manicomio, tanto che con il processo di deospedalizzazione successivo alla legge Basaglia molti sono venuti a sapere di avere parenti anche di primo grado in manicomio di cui non avevano sentito parlare perché la famiglia aveva applicato una vera damnatio memoriae ai loro danni. Nell’ambito del terzo tassello del nostro progetto, legato alle memorie più recenti, medici, infermieri e personale mi stanno raccontando alcuni casi eclatanti.
Alla luce dei suoi studi, e considerati anche i cambiamenti nell’istituzione degli ultimi tempi, ci sono elementi nell’istituzione psichiatrica italiana che ancora la preoccupano?
Tanto è stato fatto. Il problema, ora, è scardinare il pregiudizio per cui le persone con disturbi mentali sono pericolose. Per esempio, la prima cosa che spesso le cronache dicono in caso di un omicidio è che il killer è “uno squilibrato”, perché questo ci serve a rassicurarci e deresponsabilizzarci. C’è anche il problema della violenza e dei soprusi nelle strutture, ma a quanto ne so sono casi isolati. E resta aperta ancora oggi la questione degli istituti psichiatrici giudiziari, che secondo me sono un po’ quello che resta di quella grande aberrazione che sono stati i manicomi in Italia.

Raffaella Firpo
Ex insegnante di lettere lascia tutto e si dedica all’agricoltura biologica, sceglie Capriglio, un paesino del Monferrato.
” Quando arrivai ero guardata di traverso perché ero cittadina e perché piantavo fiori in mezzo alle piante di pomodoro. Il Fiore era il tagete e serviva a tener lontani i parassiti”
A Capriglio, ascoltando gli anziani, scopre un ortaggio: un peperone piccolo come una mela a forma di cuore, dolce e con proprietà organolettiche speciali ma poco appetibile per il grande commercio e quindi destinato al l’estinzione.
Lei recupera i semi e lo coltiva.
Oggi il peperone di Capriglio é pregiatissimo.
Brava Raffaella!

Ursula, la capitana d’Europa
Ursula von der Leyen é arrivata dove nessuna donna prima aveva mai messo piede.
É Lei la Presidente della Commissione Europea, bellezza nordica un pó démodé dallo sguardo fulminante.
Respira politica in famiglia, a 28 anni si sposa e mette al mondo sette figli, é per molti versi progressista, sicuramente una donna forte, tenace e determinata.

Tropea a Ottobre é rosa
Lo Scoglio dell’ Isola si illumina di rosa perché Tropea aderisce alla campagna di prevenzione del tumore alla mammella.
E tu, Donna, ricorda che al primo posto si colloca uno stile di vita sano!
Le regole di salute sono semplici, seguile anche tu: smetti di fumare, se vuoi bere alcolici fallo con moderazione senza mai superare un bicchiere al giorno, non nutrirti di grassi e zuccheri, scegli per la tua dieta frutta, verdura, cereali integrali, fai sport tutti i giorni, non ingrassare e stai attenta alla pancetta che rappresenta il grasso più pericoloso. Esegui regolari controlli senologici e, soprattutto, fai di tutto per ridurre e, possibilmente, eliminare fattori di stress.

Grazie
Voglio ringraziare
per la notte e la pioggia
che ci restituisce la memoria della madre.
Grazie per il vento
che ci fa stranieri di noi stessi
e per la pietra
che aspira a sognare l’eternità.
Voglio ringraziare per i bambini
che non conoscono né la colpa né la morte,
e per la musica,
anima trascesa in epifania.
Grazie per la luce che ci dona il mare
e per l’aria frizzante e salubre.
Grazie per la bellezza che ci colma e ci intimidisce
e per l’alba
che ci offre l’illusione della prima volta.
Grazie
per la gioventù e per i sensi
per l’alloro e per il grano.
Grazie
per il prato, più tenace del tempo,
e per l’arte,
che ci trascende e sopravvive.
Voglio ringraziare
per i giorni che dividi con me,
per la carezza e per il bacio.
Grazie per il mare, assoluto e potente.
Grazie per il silenzio e per la poesia.
(Xulio López Valcárcel)
Sono una ragazza di 28 anni
Senatrice Lina Merlin Senato della Repubblica
Lettere a Lina
Senatrice Lina Merlin Senato della Repubblica
